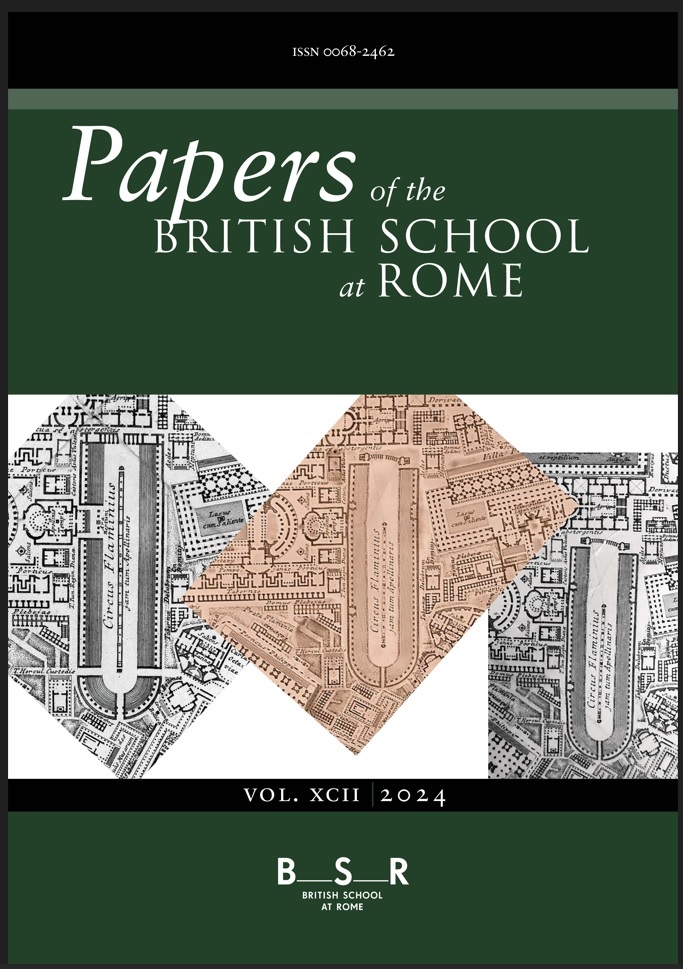1. UN'INEDITA DEDICA A VIRTVS NEL CHIOSTRO DI MICHELANGELO ALLE TERME DI DIOCLEZIANO (INV. 113202)
Presso l'angolo occidentale del Chiostro di Michelangelo al Museo delle Terme di Diocleziano è esposta una statua acefala e priva anche di braccia (Figg. 1–6), in vesti militari, con iscrizione sul plinto, rivelatasi inedita.Footnote 2

Fig. 1. Statua con dedica a Virtus, fine II e inizi III secolo d.C., calcare, dimensioni del plinto cm 23 x 45 x 37; altezza della statua cm 110. Roma, Museo Nazionale Romano (Terme di Diocleziano). Inv. 113202 (© Marco Brunetti, Simone Ciambelli, Gian Luca Gregori, su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Museo Nazionale Romano).

Fig. 2. Dettaglio (© Marco Brunetti, Simone Ciambelli, Gian Luca Gregori, su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Museo Nazionale Romano).

Fig. 3. Dettaglio (© Marco Brunetti, Simone Ciambelli, Gian Luca Gregori, su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Museo Nazionale Romano).

Fig. 4. Dettaglio (© Marco Brunetti, Simone Ciambelli, Gian Luca Gregori, su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Museo Nazionale Romano).

Fig. 5. Dettaglio (© Marco Brunetti, Simone Ciambelli, Gian Luca Gregori, su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Museo Nazionale Romano).

Fig. 6. Dettaglio (© Marco Brunetti, Simone Ciambelli, Gian Luca Gregori, su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Museo Nazionale Romano).
Il plinto misura cm 23 x 45 x 37, mentre l'altezza complessiva della statua, attualmente di circa cm 110, doveva originariamente raggiungere con la testa (elmata?) cm 120-130. La statua e la base sono state ricavate dal medesimo blocco; la superficie superiore del plinto è stata scalpellata, mentre il fianco destro, quello sinistro e il retro si presentano solo sbozzati grossolanamente. Ciò farebbe pensare che la statua fosse stata in origine addossata ad una parete, oppure inserita in una nicchia. La cornice che delimita il campo epigrafico è lievemente danneggiata nella parte inferiore della fronte e in quella inferiore del lato destro. Il testo è caratterizzato da un'esecuzione accurata delle lettere che hanno un'altezza di cm 2-2.5. Alcune lettere dell'ultima linea sono lievemente danneggiate, ma la lettura è sicura. Tracce di rubricatura si possono ancora osservare nel solco di alcune lettere; una hedera è presente r. 2. La statua entrò a far parte della collezione del Museo il 10 giugno 1932 (inv. 113202). La scheda inventariale ci informa che fu rinvenuta non a Roma, ma lungo l'antica via Clodia nei pressi del santuario di Santa Maria in Celsano (Santa Maria di Galeria, Municipio XIV di Roma Capitale). Dal catalogo delle Terme di Diocleziano del 1954 apprendiamo che la statua era allora collocata nell'Aula VII del Museo (Aurigemma, Reference Aurigemma19543: 49, no. 111).
Questo il testo inciso sul plinto (Fig. 7):
Virtuti corp(oris vel -oratorum) coll(egi) dendropho=
rum vici Cariensibus
Q(uintus) Fabius Eutychianus patronus et
q(uin)q(uennalis) p(er)p(etuus) de suo posuit.
r. 1-2: dendrophorum pro dendrophororum, per un fenomeno di metaplasmo ampiamente documentato nelle iscrizioni; 2 Cariensibus pro Careiensibus, causa sincope.

Fig. 7. Dettaglio (© Marco Brunetti, Simone Ciambelli, Gian Luca Gregori, su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Museo Nazionale Romano).
Traduzione: ‘Al Valore della collettività del collegio dei dendrofori del vicus, per gli abitanti di Careiae, Quinto Fabio Eutichiano patrono e presidente perpetuo a sue spese pose’.
Il testo è di chiara lettura, ma non di immediata comprensione. La sua interpretazione ruota attorno al valore da attribuire a Cariensibus a r. 2, etnico degli abitanti di Careiae, una statio a 15 miglia da Roma. Di norma, dopo la menzione del vicus, termine che qualifica l'insediamento come privo di autonomia amministrativa, ci saremmo aspettati l'etnico al genitivo plurale (Careiensium) e non un dativo. Poco probabile sembra un errore del lapicida, sebbene questa possibilità non sia del tutto da scartare. È necessario quindi ragionare sul valore da attribuire a questo dativo. Scartando l'ipotesi di un dativo di possesso, l'interpretazione più plausibile sembra quella di un dativo di vantaggio: la statua, dedicata alla Virtus dei dendrofori, sarebbe stata eretta a vantaggio degli abitanti di Careiae. Purtroppo, questa insolita costruzione, con due dativi, non sembra avere riscontri stringenti nella documentazione epigrafica in Italia.
Un'ulteriore particolarità riguarda la sequenza delle due abbreviazioni CORP. COLL. (r. 1). Il primo termine sembra riferirsi a corpus, da intendere forse come designazione della collettività che componeva l'associazione, il secondo, invece, a collegium, da interpretare come l'istituto che accoglieva i singoli membri.Footnote 3 La ridondanza di questa formulazione, seppur secondo una grafia differente, è attestata in un'altra iscrizione onoraria proveniente da Praeneste per indicare le collettività che componevano l'insieme dei collegia cittadini, beneficiari di sportulae da parte dell'onorato M. Aurelius Iulius Eupraepes. Footnote 4 Tale formulazione potrebbe essere giustificata dalla natura della dedica: è usuale, infatti, che la Virtus come entità astratta sia connessa a persone, quindi nel nostro caso ai componenti del collegio, e non all'istituzione in sé.Footnote 5
Ciononostante, i due termini potrebbero essere sciolti anche diversamente: corp(oratorum) coll(egi). In tal caso il primo termine farebbe riferimento ai membri e il secondo al collegio.Footnote 6 La ridondanza troverebbe anche qui la sua giustificazione nella connessione della Virtus con le persone (corporati) e non con l'istituzione (collegium). Seguendo questa seconda linea interpretativa si potrebbe supporre che con corporati si volesse alludere ai soli membri ordinari dell'associazione, con esclusione dei magistrati e dei patroni, secondo un uso, invero piuttosto raro, attestato in alcuni alba collegiali,Footnote 7 ma che non sembra trovare riscontro nelle dediche.Footnote 8 Sebbene questo scioglimento implichi forse un'eccessiva abbreviazione del termine corporatorum non è da escludere a priori in quanto attestata anche in altre iscrizioni.Footnote 9
A parte queste difficoltà di interpretazione, è la dedica stessa alla Virtus ad essere problematica o quantomeno insolita.Footnote 10 Sino ad ora, infatti, in tutto l'Occidente romano, si conosceva un'unica attestazione di Virtus in relazione con un collegio: una piccola colonna di marmo che aveva la funzione di sorreggere una statuetta argentea della Virtus, donata ai dendrofori di Ostia da Iulia Zosime, mater del collegio.Footnote 11 Essa è stata rinvenuta presso il Campo della Mater Magna (Regio IV, Insula I), probabilmente dove era la sede stessa del collegio, e risalirebbe a un arco di tempo compreso tra il II e la prima metà del III secolo.
Dunque, le due attestazioni di Virtus in ambito collegiale riguardano per ora unicamente associazioni di dendrofori. Secondo l'ipotesi formulata da Maria Floriani Squarciapino (Reference Squarciapino1962: 8-9) per l'iscrizione ostiense, questa connessione potrebbe essere dovuta al legame esistente tra il culto di Cibele e quello di Bellona. Quest'ultima non sarebbe da intendere infatti come l'antica divinità della guerra di probabile origine sabina, ma come la romanizzazione della dea anatolica Ma,Footnote 12 introdotta a Roma da Silla dopo la guerra contro Mitridate (Plut., Sull. 9, 7-8; 27, 12; Mann, Reference Mann2008: 545-8). A Roma questa divinità, dalle preminenti caratteristiche guerresche ma connessa anche con la fertilità, fu da subito identificata con Bellona e venerata contestualmente a Cibele.Footnote 13 Il culto di Ma-Bellona in epoca imperiale, oltre a intersecarsi con quello di Mater Magna, si confuse sempre più con quello di Virtus nella sua accezione militare riportata in auge dalla propaganda imperiale.Footnote 14
Tuttavia, il rapporto con Virtus potrebbe essere spiegato anche indipendentemente da Bellona se si considera che la Mater deum, rappresentata con una corona murale in testa, assume sin dal suo arrivo a Roma il ruolo di protettrice dei Romani, apportatrice di vittoria e salvezza. Nel suo ingresso a Roma, infatti, la dea segue un percorso di tipo militare, passando attraverso porta Capena, davanti sia al tempio di Marte che a quello di Honos et Virtus (Van Haeperen, Reference Van Haeperen2019a: 70-73, 184). In ogni caso, l'esaltazione della Virtus del collegio dei dendrophori, che sappiamo essere connesso al culto di Mater Magna per mezzo del suo paredro Attis, Footnote 15 non appare sorprendente e sembra inserirsi perfettamente entro una cornice cultuale caratterizzata anche da sfumature guerresche.
Passando al dedicante della statua, Quintus Fabius Eutychianus, egli è noto anche da un'altra iscrizione (vd. infra, 3). Il suo cognome grecanico suggerisce una nascita non ingenua o almeno una discendenza libertina. Egli riuscì comunque a compiere una brillante carriera all'interno del collegio, sino a divenirne presidente e ad essere insignito della carica onorifica di quinquennalis perpetuus. Footnote 16 Il suo ruolo di preminenza all'interno dell'associazione, e forse anche all'interno della piccola comunità di Careiae, gli valse la cooptatio patroni da parte della sua stessa associazione, nomina che lo elevò al di sopra del resto dei collegiati. Footnote 17
2. LA PRIMA ATTESTAZIONE EPIGRAFICA DELL'ETNICO CAREIENSES
Tra le varie particolarità della nuova iscrizione vi è anche il fatto che essa contenga la prima menzione dell'etnico Carienses (in luogo della forma corretta Careienses), da riferire alla piccola comunità di Careiae, nell'Etruria meridionale, che ora apprendiamo avere avuto lo status di vicus. Finora essa era nota solo dagli itinerari, la Tabula Peutingeriana (5.4), l’Itinerarium Antonini (300.2) e il Geografo Ravennate (274.8), come luogo di sosta lungo la via Clodia, ricalcata oggi, per diversi tratti, dalla SP 493 Claudia Braccianese. L'antico sito verrebbe a trovarsi nella parte meridionale del centro radiotrasmittente di Santa Maria di Galeria (Municipio XIV di Roma Capitale), di proprietà della Santa Sede e con il privilegio dell'extraterritorialità (Fig. 8a).Footnote 18

Fig. 8a. Porzione del territorio di Santa Maria di Galeria, Municipio XIV di Roma Capitale, con il percorso dell'antica Via Clodia e l'attuale tragitto della SP 493 via Claudia Braccianese; in evidenza il santuario di Santa Maria in Celsano e il sito di Careiae. Immagine tratta da Google Maps, modificata (© Simone Ciambelli).
Il toponimo compare anche in Frontino, a proposito del passaggio dell’aqua Alsietina, che fu rafforzata con un condotto proveniente dal lacus Sabatinus. Footnote 19 Il centro, prossimo al fiume Arrone, si sviluppava a Ovest di Veio e a Sud di Caere; è tuttora incerto se esso rientrasse nel territorio ceretano (cosa che ne presupporrebbe un'ampia estensione verso Est), o in quello veientano;Footnote 20 Eugen Bormann, editore di CIL XI, a sua volta (CIL XI: 70), pensava alla vicina prefettura di Forum Clodii, cui la mansio era collegata per il tramite della via Clodia (Fig. 8b).

Fig. 8b. Porzione del territorio dell'Etruria Meridionale compreso tra il Lago di Bracciano e Roma; in i centri di Caere, Careiae, Forum Clodii, Roma e Veii. Immagine tratta da Google Maps, modificata (© Simone Ciambelli).
Provenienti dal territorio attribuito a Careiae si conoscono finora soprattutto iscrizioni sepolcrali (CIL XI 3759-3776), inquadrabili nei primi due secoli dell'Impero, che non aiutano a risolvere il problema della sua attribuzione a questo o a quel municipio più o meno vicino.
3. CIL VI 480 = 30775 (KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, WIEN, INV. I 1182)
La notizia relativa alla provenienza da Santa Maria in Celsano della statua di Virtus consente ora di riconsiderare come non urbana anche una statua di Marte, alta cm 95, con ricco cimiero (di restauro), spada nella mano destra (perduta) e scudo rotondo nella sinistra, in atto di avanzare con la gamba sinistra, su plinto recante un'iscrizione di tre righe (cm 9 x 40 x 21; lett. cm 1.8-1.4) e sulla cui provenienza mancano dati precisi. Sappiamo che nel Cinquecento essa appartenne alla ricca collezione del cardinale Rodolfo Pio da Carpi sul Quirinale (Solin, Reference Solin, Bianca, Capecchi and Desideri2009: 117-52), prima di passare a Venezia, presso i Grimani e giungere poi nella raccolta del marchese Tommaso degli Obizzi (1750-1803), presso la villa del Catajo a Battaglia Terme (in provincia di Padova) (Tozzi, Reference Tozzi2017); alla fine dell'Ottocento, con gran parte di quella collezione, fu trasferita nel Kunsthistorishes Museum di Wien, dove tuttora si conserva nei depositi (Fig. 9).Footnote 21

Fig. 9. Statua di Marte, fine II e inizi III d.C., marmo, altezza totale cm 103.5; altezza della statua cm 95. Wien, Kunsthistorisches Museum. Inv. I 1182 (© Wien - Kunsthistorisches Museum, Foto: Dipartimento dei Beni Culturali, Laboratorio di Epigrafia e Papirologia dell'Università di Padova 2016/17).
La statua è sempre stata ritenuta urbana, ma siccome il dedicante sembra essere lo stesso della statua di Virtus, possiamo ipotizzare che la seconda fosse arrivata a Roma dal territorio dell'antica Careiae (Fig. 10):Footnote 22
Deo sancto Marti
Q. Fabius Eutychianus patron(us)
et q(uin)q(uennalis) p(er)p(etuus) de suo posuit.

Fig. 10. Dettaglio (© Marco Brunetti).
Non sembra esserci dubbio che il dedicante sia lo stesso della statua di Virtus, sia per la perfetta corrispondenza per quanto riguarda l'onomastica, sia per le funzioni ricoperte presso il collegio dei dendrofori, anche se in questo secondo testo il nome dell'associazione non compare, circostanza spiegabile se la statua era esposta nella schola del collegio stesso; meno significativo il fatto che si sia fatto ricorso alla medesima formula finale (de suo posuit), essendo essa in generale alquanto comune.
L'accostamento della statua di Marte con quella di Virtus permette ora di riferire anche la prima al collegio dei dendrophori, mentre finora si pensava a ‘Vorstand eines Vereins oder der lokalen Tempelgemeinde’ (Kränzl e Weber, Reference Kränzl and Weber1997: 62; cf. Ausbüttel, 1986: 50 no. 7). Non mancano nell'epigrafia delle città italiche confronti per personaggi di probabile condizione libertina, come il nostro Eutychianus, Footnote 23 che ricoprirono importanti funzioni presso le associazioni dei dendrofori,Footnote 24 così come sono noti altri casi di evergetismo,Footnote 25 anche se più spesso sono attestate dediche di statue da parte dei collegi per i loro presidenti e/o patroni.
Particolarmente significativo, per quanto riguarda l'associazione di Marte con i dendrofori, è il confronto offerto da una seconda iscrizione ostiense, menzionante il quinquennale T. Annius Lucullus, che a Ostia nel 143 d.C. donò un signum Martis al locale collegio.Footnote 26
Viene spontaneo domandarsi se il fatto di trovare solamente ad Ostia e a Careiae dediche a Virtus e a Mars entrambe connesse con i dendrofori sia una semplice coincidenza o non si possa piuttosto spiegare con la provenienza ostiense del dedicante, essendo un Q. (?) Fabius Honoratus attestato al tempo di Lucio Vero a Ostia proprio nel collegio dei dendrofori, che a lui conferì l’immunitas (CIL XIV 107 = Vermaseren, Reference Vermaseren1977: no. 408 = EDR163540). Si aggiunga che diversi Quinti Fabii di origine libertina figurano nell'albo dei lenuncularii tabularii ostiensi del 192 d.C.Footnote 27 D'altra parte il gentilizio Fabius, nella regio VII, è alquanto diffuso, anche con il prenome Quintus, ma non nel triangolo Forum Clodii-Veii-Caere.
Non si riscontrano in Italia altre dediche sacre rivolte deo sancto Marti, formulazione che invece conosce qualche confronto nelle province occidentali;Footnote 28 se rare sono nella regio VII le testimonianze epigrafiche del culto di Marte,Footnote 29 ancora più circoscritte si presentano quelle di Virtus: seguita da genitivo essa si ritrova solo presso il lago di Bolsena, in una dedica Virtuti Visentium. Footnote 30
Le due iscrizioni sacre, provenienti entrambe con grande probabilità da Careiae, vanno anche ad accrescere il modesto dossier epigrafico relativo ai dendrophori dell'Etruria, finora limitato a pochi casi da Fiesole e Luni (CIL XI 1551 = EDR103150; 1355b = EDR129457).
Quanto alla datazione delle due statue, si deve trattare di due doni contestuali, in quanto del tutto simili sono i caratteri paleografici, connotati da uno spiccato modulo rettangolare e dai tratti orizzontali di E, F, T svolazzanti; essi, insieme all'epiteto deo attribuito a Marte, sembrano suggerire un inquadramento cronologico attorno alla prima età severiana, dal momento che il dedicante presenta nella sua onomastica ancora il prenome.Footnote 31
Sia Careiae da attribuire all'agro di Veii, di Caere o di Forum Clodii, le nostre iscrizioni vanno a incrementare il rispettivo dossier epigrafico inquadrabile nel III sec., certamente modesto, soprattutto per Caere, ma sufficiente a dimostrare che i tradizionali organismi amministrativi erano ancora in funzione in tutti e tre i centri.Footnote 32
4. LA STATUA DI VIRTVS: ASPETTI MATERIALI, STILISTICI E FUNZIONALI
La statua calcarea nel Chiostro di Michelangelo alle Terme di Diocleziano è di dimensioni minori del naturale e ritratta in posizione stante su di un plinto quadrangolare; risulta mutila della testa, delle spalle, delle braccia e della caviglia sinistra.
A un primo sguardo, oltre alle affinità epigrafiche sopra menzionate, anche nelle dimensioni e nell'abbigliamento loricato, la statua del MNR mostra alcune somiglianze con la scultura di Vienna. Tuttavia, a un esame più attento, è proprio nelle differenze che si celano gli aspetti di maggior interesse. L'elemento che più di tutti distingue i due manufatti riguarda la postura del corpo. Mentre la statua del MNR è ritratta a riposo con ponderazione, quella viennese rivela una gestualità che, seppur in modo piuttosto rigido, denota un'azione in corso (Fig. 9). La figura è infatti protesa in avanti con la gamba destra leggermente indietreggiata e il tallone sollevato. Nel braccio sinistro sollevato che regge lo scudo, si coglie il tentativo di difesa da un attacco e, nella mano destra che impugna il gladio, la volontà di ricambiare l'offesa. Anche nell'abbigliamento si notano delle evidenti differenze tra le due statue. Seppur entrambe indossino la lorica anatomica e pteryges, la statua del MNR è coperta da un lungo mantello (paludamentum) che dalle spalle arriva fino alle caviglie. Nel caso della statua viennese, il mantello appare invece di dimensioni ridotte e raccolto nel braccio sinistro. Inoltre, nella statua del MNR mancano alcuni dettagli, come i lacci all'altezza del ventre per legare la lorica, gli schinieri e le caligae. Al posto di queste ultime, soprattutto nel piede destro, si riconoscono delle calzature di più ordinario utilizzo del tipo ‘stivaletto’, verosimilmente perones/calcei. Le calzature sembrano essere di un tessuto morbido che lascia intravedere la conformazione del piede.
Entrambe le statue presentano un tronco come supporto statico. La conformazione a forma di tronco per quest'ultimo è un tipico espediente iconografico utilizzato dai lapicidi e, perciò, non riconducibile a un particolare significato simbolico (Anguissola, Reference Anguissola2018). Infine, nel caso della statua viennese e di quella del MNR, la parte retrostante della figura è sommariamente sbozzata, facendo supporre una visibilità solo frontale. Inoltre, anche i lati del plinto su cui poggia la statua del MNR sono rozzamente sbozzati (Fig. 2).
La statua del MNR ha sicuramente sofferto di condizioni conservative più ostili rispetto al manufatto viennese, come mostrano le numerose lacune e soprattutto l'usura delle superfici e l'annerimento dei piedi – quest'ultimo dovuto probabilmente all'umidità del contesto di rinvenimento, purtroppo sconosciuto (Fig. 6). Ovviamente, quello che oggi si vede nella statua viennese è frutto di importanti interventi di restauro e integrazioni nel corso del tempo.Footnote 33 Tuttavia, prescindendo dallo stato di usura e dalle lacune, la statua del MNR si caratterizza comunque per una fattura decisamente meno curata e raffinata rispetto all'esemplare viennese. Innanzitutto, lo stesso materiale calcareo della statua del MNR, a dispetto del marmo impiegato per la statua viennese, ne rivela un costo inferiore. Inoltre, alcuni dettagli anatomici e dell'abbigliamento (come la muscolatura della gamba e le pieghe dei pteryges) suggeriscono una produzione artigianale di livello non altissimo – forse più esperta nella replica meccanica che in una lavorazione di pregio. Infine, la statua del MNR rivela alcuni dettagli che suggeriscono una realizzazione non del tutto ultimata, come si vede nella parte interna del paludamentum, in cui manca qualsiasi accenno alle pieghe o eventuali dettagli tessili (es. bordi/risvolti). Anche la parte terminale del plinto offre un dettaglio difficilmente ascrivibile a una semplice negligenza del lapicida. Alla base di quest'ultimo, si può infatti notare come il limite tra la superficie levigata – su cui si trova l'iscrizione – e la parte inferiore sbozzata sia fortemente irregolare e inclinato. È vero che la statua poteva essere inserita all'interno di una superficie incava che avrebbe coperto alcuni centimetri del podio iscritto. Tuttavia, la distanza tra l'ultimo rigo dell'iscrizione e il limite sopra menzionato è alquanto breve (circa 3 cm).
Data la fattura grossolana del manufatto e le condizioni di conservazione, la cronologia della statua del MNR è perlopiù suggerita dalle caratteristiche epigrafiche sopra menzionate che la pongono attorno all'età severiana. Sebbene l'iscrizione della statua del MNR riporti la dedica a Virtus, si evince un problema relativo all'iconografia e, soprattutto, al genere sessuale della figura riprodotta. Infatti, osservandone l'anatomia, non si riscontrano chiari elementi per un'identificazione del genere femminile e, tanto più, per il riconoscimento della figura come Virtus. Come mostrato da Thomas Ganschow (Reference Ganschow1997; cf. McDonnell, Reference McDonnell2006: 142-58), l'iconografia di Virtus – intesa come valore militare e non più generalmente come traduzione della greca Aretè – deriva dall'iconografia greca della Amazzoni proprio a motivo del loro valore militare. Le iconografie, testimoniate soprattutto da monete e rilievi, concordano nel rappresentare la personificazione di Virtus come una figura femminile vestita di elmo, morbido chitone legato alla vita, seno scoperto e stivali. Nella statua del MNR tali dettagli non sono in alcun modo riscontrabili, a eccezione dei perones/calcei. Sono soprattutto tre elementi a suggerire il fatto che siamo di fronte a una figura maschile: la presenza della lorica, la fisionomia di quest'ultima e la muscolatura (comprese le gambe). Ovviamente, tale presenza maschile al di sopra di una dedica alla Virtus rende l'esegesi del manufatto particolarmente complessa. Mentre infatti la statua viennese riporta una dedica a Marte e una conseguente rappresentazione del dio, ciò non si verifica nel caso della statua del MNR. A oggi, non sono stati individuati casi analoghi di discrasia tra iscrizione e rappresentazione – né nella statuaria votiva né, più specificatamente, in quella votiva pertinente a scholae. Footnote 34 In tal senso, piuttosto che ipotizzare un imperatore (non citato nell'iscrizione), rimane aperta la possibilità che la figura rappresenti lo stesso dedicante, Quinto Fabio Eutichiano, oppure che si tratti di un riutilizzo di una statua di Marte alla quale venne adattata una dedica a Virtus per la sua stretta connessione con il valore militare.Footnote 35
Difficile immaginare se la statua del MNR poggiasse su di un altare, come nel caso della statua di Diana Nemesis, rinvenuta nell'anfiteatro I dell'antica Carnuntum, vicino a Bratislava (Fig. 11) (Buora e Jobst, Reference Buora and Jobst2002: 276, cat. Vd.1 e Vd.2).

Fig. 11. Statua di Diana Nemesi, 200-220 d.C., arenaria, altezza cm 169.5. Bad Deutsch Altenburg, Museum Carnuntinum. Inv. 28, 3772 (K 14/05) (© lupa.at/4925, foto O. Harl).
Il plinto di questa statua è molto simile per dimensioni e conformazione a quello della statua di Marte a Vienna. Mentre però nella statua di Diana non compare un'iscrizione (perché quest'ultima si trovava sull'altare) (Fig. 12),Footnote 36 nel caso della statua viennese e in quella del MNR, la presenza dell'iscrizione sul plinto farebbe pensare a un eventuale supporto non iscritto. Nel caso della statua del MNR, vista l'altezza del plinto, è facile pensare che la scultura dovesse avere un supporto (incavo?) di ridotte dimensioni.

Fig. 12. Altare della Statua di Diana Nemesi, 200-220 d.C., arenaria, altezza cm 87; larghezza 45; profondità 63. Bad Deutsch Altenburg, Museum Carnuntinum. Inv. 28, 3772 (K 14/05) (© lupa.at/4925, foto O. Harl).
Rimane ovviamente del tutto ignoto il luogo in cui le statue di Vienna e del MNR fossero originariamente collocate. Sicuramente, nel caso della statua del MNR, il riferimento al collegium dei dendrophori suggerisce l'appartenenza della scultura al collegium stesso. Purtroppo, come mostrano gli studi di Beate Bollmann (Reference Bollmann1998: 127-55; cf. Goffaux, Reference Goffaux2016; Tran et al., Reference Tran, Rodríguez Reséndiz, Soler Mayor, Goffaux, Rodríguez, Tran and Soler2016), la variabilità edilizia e architettonica delle scholae non permette di attribuire a determinati arredi scultorei precise disposizioni spaziali, sebbene venissero spesso riservate posizioni all'interno di nicchie o esedre. In alcuni casi, la stessa schola non era neppure strutturata architettonicamente come edificio indipendente. Per esempio, nel caso appena menzionato della statua di Diana, quest'ultima è stata rinvenuta all'interno di uno spazio cultuale annesso all'anfiteatro I della città (Buora e Jobst, Reference Buora and Jobst2002: 276, cat. Vd.1 e Vd.2). Analogamente, a Roma, la Curia (o schola) athletarum, dedita al culto di Herakles, era annessa alle Terme di Traiano sul colle Oppio (Caldelli, Reference Caldelli1992). Ecco che perciò, nell'immaginarci la sede dei dendrophori di Careiae, non necessariamente bisogna supporre la presenza di un edificio a sé stante, ma poteva configurarsi anche come un ambiente annesso a un edificio pubblico – un edificio semi-pubblico (‘halböffentlich’), come definito da Lauter (Reference Lauter2009: 117-8).
Le scholae di dendrophori riconosciute finora con certezza dagli archeologi sono poche e (anche nei casi altamente verosimili, come la Basilica Hilariana a Roma) la documentazione scultorea superstite è veramente esigua (Pavolini, Reference Pavolini2013: 381-422; Reference Pavolini2020). Come ha messo in evidenza Carlo Pavolini (Reference Pavolini2013: 461-75), presso le scholae dei dendrophori, uno spazio sacro doveva essere riservato all’arbor sancta di Attis e, verosimilmente, anche agli oggetti cultuali, portati in processione in occasione della celebrazione dell’arbor intrat. Footnote 37 Brian Madigan (Reference Madigan2013: 101) ha recentemente riconsiderato l'altare conservato nel Fitzwilliam Museum di Cambridge, dedicato al culto di Cibele e datato alla fine del II secolo d.C. e inizi del III (Fig. 13).Footnote 38

Fig. 13. Cosiddetto “altare di Cibele” (dettaglio di uno dei lati), fine del II secolo d.C. e inizi del III, 36.6 x 43 x 42.5 cm. Cambridge, Fitzwilliam Museum. Inv. GR5.1938 (© The Fitzwilliam Museum, Cambridge).
Secondo la sua interpretazione, nell'altare sarebbe rappresentato il sellisternium, ossia la processione durante la quale alcuni membri del collegio vestiti alla moda frigia trasportavano un ferculum, sopra il quale si trovava il trono della dea e la cista, rappresentazione simbolica di quest'ultima (Gordon, Reference Gordon, Giuffrè Scibona and Mastrocinque2012: 207; Karković Takalić, Reference Karković Takalić, Fontana and Murgia2018: 375). Sempre sull'altare, ai lati si vedono due statuette maschili che reggono una trave decorata da rami di pino, ulteriore riferimento al collegio dei dendrophori e al loro culto di Mater Magna e Attis.
Ovviamente, nel caso della statua del MNR, la tipologia dell'oggetto, le sue dimensioni e la limitata rilevanza stilistica non permettono di considerarlo come arredo da parata, ma come semplice ornamento votivo o commemorativo – come abitualmente erano le statue all'interno delle scholae. Footnote 39
5. RIFLESSIONI SUI DENDROFORI A CAREIAE
I collegia dei dendrophori assieme a quelli dei centonarii e dei fabri sono i meglio attestati a livello epigrafico nel mondo romano.Footnote 40 Il sostantivo dendrophorus, di chiara matrice greca, è traducibile letteralmente come portatore d'albero (δένδρον “albero” e ϕέρω “porto, portare”). Questa associazione, infatti, coinvolta nel culto di Mater Magna e del suo paredro Attis, aveva il compito principale di condurre il sacro pino durante la processione dell’arbor intrat (22 marzo), albero nel quale si sarebbe trasformato Attis dopo essersi evirato ai suoi piedi (Van Haeperen, Reference Van Haeperen, Bonnet and Sanzi2018: 36). Questa dendroforia fu istituita dall'imperatore Claudio, probabilmente nel momento stesso in cui furono iscritte pubblicamente nel calendario romano le cerimonie per Attis. Footnote 41 Come afferma Françoise Van Haeperen (Reference Van Haeperen, Dondin-Payre and Tran2012a: 48), non sembra dunque un caso che i dendrofori di Roma celebrassero come giorno della loro nascita proprio il primo agosto, dies natalis di Claudio; è assai probabile, infatti, che anche l'introduzione di questo collegio urbano sia da connettere all'azione di governo di questo imperatore.Footnote 42
La diffusione capillare dei dendrofori in numerose realtà urbane dell'Occidente romano e il loro accostamento in diverse iscrizioni ai fabri e ai centonarii hanno spinto la maggior parte degli studiosi ad attribuire loro anche un ruolo professionale connesso al trasporto e alla lavorazione del legno.Footnote 43 Tuttavia, tenendo in considerazione il totale silenzio delle nostre fonti a questo proposito e appoggiandosi ad una recente tendenza affermatasi tra gli specialisti, si può ipotizzare che i dendrophori fossero in realtà del tutto estranei alla lavorazione del legno.Footnote 44 Essi, in quanto associazione, sono da considerare legati unicamente al culto metroaco, nel quale rivestivano un ruolo non secondario in quella che è stata spesso definita “la settimana santa di Attis” (Borgeaud Reference Borgeaud1996: 131).
A Careiae, dunque, l'attestazione di un collegio di dendrofori sembrerebbe fornire un chiaro indizio di un culto di Mater Magna. Entrambe le statue dedicate da Eutychianus si sarebbero potute vedere molto probabilmente presso un locale tempio della Mater Magna, oppure nella schola dei dendrofori, che poteva sorgere nelle vicinanze del tempio stesso. Nel caso in cui il dedicante avesse infatti ricoperto le sue funzioni presso un collegio attivo altrove, egli non avrebbe verosimilmente omesso di specificarlo.
Se, come traspare dalla piuttosto vaga nota d'ingresso al Museo, la statua di Virtus fu rinvenuta nei pressi del santuario di Santa Maria in Celsano, non è da escludere che proprio in questo sito fosse anticamente praticato il culto di Cibele. L'attuale santuario insiste del resto su strutture romane di epoca imperiale (Giacobelli Reference Giacobelli1991: 13). Si potrebbe ipotizzare, con la dovuta cautela, che alla base della continuità funzionale di questo luogo, che avrebbe ospitato un culto per Cibele prima di divenire sede di un santuario dedicato alla Vergine Maria, possa esserci stato anche un qualche intreccio tra il culto metroaco e quello mariano in epoca tardoantica.Footnote 45 Il supposto complesso cultuale sarebbe sorto in aperta campagna, nelle immediate vicinanze dell'abitato di Careiae che, in base ad alcuni rinvenimenti archeologici, sarebbe da collocare circa 2 km più a Nord.Footnote 46 D'altro canto, non erano rari i santuari agresti nel suburbio di Roma, tra i quali un parallelo calzante è fornito da un complesso dedicato proprio a Mater Magna in località Torre Padiglione (LT), tra Anzio e Lanuvio, che ha restituito un importante ciclo statuario (Quilici, Reference Quilici1999).
Se l'individuazione di un luogo di culto metroaco presso il santuario di Santa Maria in Celsano resta per ora solo un'ipotesi, a emergere con chiarezza dalle dediche di Eutychianus è l'esistenza di un collegio di dendrofori in una realtà vicana. Solitamente, infatti, siamo portati a considerare la città come il contesto ideale per la manifestazione e la proliferazione del fenomeno associativo. Sebbene le due iscrizioni qui prese in esame non siano isolate nel panorama delle attestazioni dei dendrofori provenienti dall'Italia e inquadrabili tra l'età severiana e la prima metà del III sec. d.C.,Footnote 47 esse offrono l'occasione di riflettere ulteriormente sulla presenza di collegia anche in realtà rurali, dove non è escluso che alcune piccole associazioni potessero rivestire un importante ruolo di aggregazione e sociabilità. Le nostre due attestazioni, tuttavia, sembrano al momento isolate e non trovare riscontri nelle altre regiones d'Italia. Ciò potrebbe essere dovuto sia all'attuale stato dell'indagine archeologica in realtà insediative secondarie, sia alla particolare condizione dei centri abitati sparsi nei dintorni di Roma; il territorio dell'Etruria meridionale gravitava di fatto sull'Urbe cui era collegato da una fitta rete di assi viari, tra i quali rientrava certamente anche la Via Clodia. Footnote 48
LISTA DELLE ABBREVIAZIONI
AE = L'Année Épigraphique, Paris 1888-.
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin 1863-.
EDR = Epigraphic Database Roma, URL: http://www.edr-edr.it/default/index.php
HD = Epigraphic Database Heidelberg, URL: http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home
RIB = Roman Inscriptions of Britain, URL : https://romaninscriptionsofbritain.org/
TLL = Thesaurus linguae Latinae, 1900-.
Ubi erat lupa = Ubi Erat Lupa, URL: http://lupa.at/