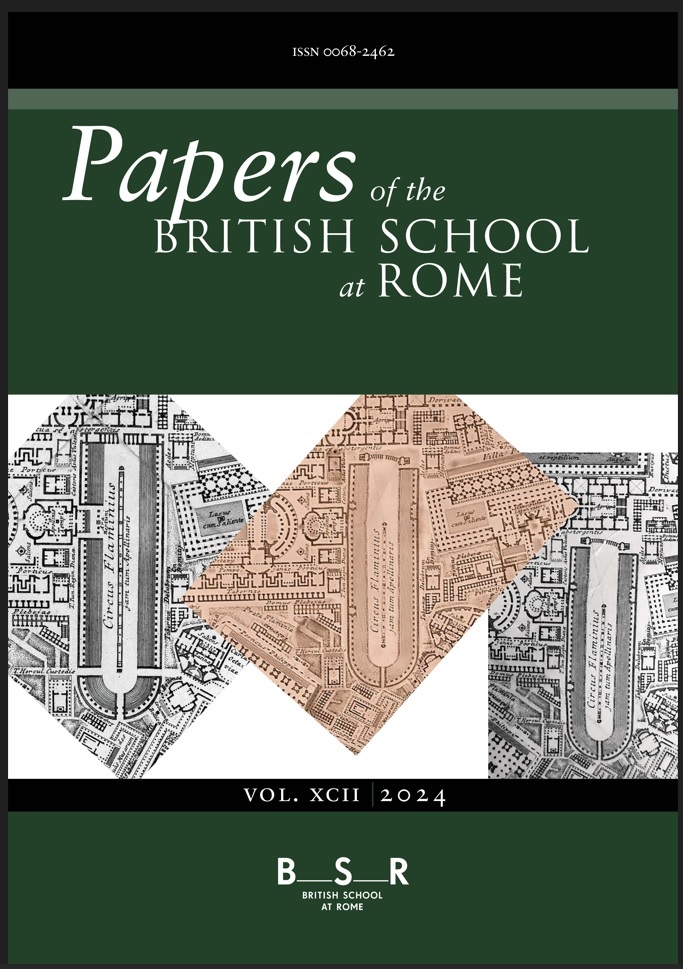INTRODUZIONEFootnote 1
Lo studio dei fenomeni legati alla cristianizzazione e alla formazione di una rete di chiese organizzata nel territorio corrispondente grossomodo all'attuale Toscana, nel periodo ascrivibile ai secoli tardo antichi ed alto medievali, è a lungo stato deficitario di tentativi di sintesi organica: questo aspetto è legato in primis ad un'impostazione di ‘scuola’, che per decenni ha privilegiato determinati filoni di studio a discapito di altri e, in secundis, alla conseguente carenza di progetti ad ampio raggio che prevedessero approfondimenti su dinamiche che, invece, furono parte integrante e costitutiva della formazione dei paesaggi e delle società post classiche.
Scopo di questo studio è, dunque, proporre una lettura di sintesi dei dati a disposizione per il territorio toscano settentrionale nell'ambito cronologico compreso tra il IV secolo d.C. e la disgregazione della Tuscia Langobardorum, nel maturo VIII secolo d.C., onde prospettare nuove chiavi di lettura dei fenomeni legati alla formazione di una topografia cristiana, sia in ambito urbano che rurale.
In età tardo antica, il territorio di nostro interesse attraversò profonde riconfigurazioni istituzionali, che ebbero significative ricadute anche dal punto di vista materiale ed insediativo. Il ‘fatto’ storico dirimente in tal senso fu la suddivisione di quella che precedentemente era nota come Regio Tuscia et Umbria in Tuscia Annonaria e Tuscia Suburbicaria, occorso in un momento inquadrabile alla fine del IV secolo d.C., sebbene le informazioni sulle tempistiche puntuali di tale ridefinizione (e sui reali confini geografici tra i due ambiti) non siano note con precisione.Footnote 2 Altrettanto complessa è l'esatta definizione cronologica circa la strutturazione della Tuscia Langobardorum sul territorio, dal momento che le fonti documentarie sono piuttosto scarse ed imprecise a tal riguardo: secondo un importante studio di C. Citter e W. Kurze (Reference Citter, Kurze and Brogiolo1995) la presenza longobarda nel territorio toscano sarebbe occorsa dapprima, alla fine del VI secolo d.C., secondo soluzioni legate maggiormente ad esigenze di razzia piuttosto che di effettivo stanziamento, mentre solo dai primissimi anni del VII l'insediamento ed il controllo politico della regione sarebbero divenuti effettivi e stabili. Il controllo longobardo sulla Tuscia sarebbe inoltre durato, di contro, alcuni decenni oltre il canonico 774 d.C., dal momento che, agli inizi del IX secolo d.C., a Lucca sussisteva un dux ancora longobardo, Allone (MD/IV: 56), con il primo vassus carolingio attestato con sicurezza dalle fonti nell'807 d.C., con la menzione di Adelgrimo, figlio di Walagrino (Andreolli Reference Andreolli1973: 69).
IMPIANTO METODOLOGICO E PROBLEMATICHE STORIOGRAFICHE
La base di partenza di questo studio si imposta su una rigorosa schedatura di tutti gli edifici di culto cristiano rintracciabili sia dall'edito, che dalle fonti scritte, nonché da sopralluoghi fisici sui monumenti finalizzati alla lettura degli elevati, ove superstiti. La messe di dati raccolta ha consentito di elaborare le articolazioni cronologiche e tipologiche delle chiese edificate nel periodo di nostro interesse, onde comprenderne, sia in ambito urbano che rurale, le evoluzioni diacroniche, i rapporti con gli abitati, le preesistenze ed i sistemi di comunicazione. In totale sono stati archiviati 231 edifici ecclesiastici, definendo una base dati i cui punti principali sono legati alle prime attestazioni delle strutture ecclesiastiche, alle evoluzioni icnografiche occorse nella lunga durata, con anche riferimenti specifici, in campi appositamente dedicati, alle preesistenze ed agli insediamenti contemporanei, ove conosciuti (Fig. 1).Footnote 3

Fig. 1. Pianta riassuntiva con l'area indagata e gli edifici di culto schedati (da Castiglia, Reference Castiglia2017).
Come chiosato, la tradizione di studi sulla ‘globalità’ dell'impatto che ebbe il cristianesimo nel territorio toscano è stata a lungo lasciata in secondo piano rispetto ad altri ambiti di studio: nonostante ciò, però, soprattutto negli ultimi quindici anni, la letteratura si è arricchita di importanti contributi e di rinnovati progetti di scavo. Lo studio ‘seminale’ sulla formazione e strutturazione della rete chiesastica nella zona qui in esame è rappresentato dal contributo di Cinzio Violante (Reference Violante1982) alla ventottesima settimana di studio del Centro Italiano di studi sull'Alto Medioevo di Spoleto del 1980, un lavoro che ha segnato generazioni di studiosi e che, negli ultimi anni, è stato magistralmente ripreso ed aggiornato in più sedi da Mauro Ronzani (Reference Ronzani2009; Reference Ronzani2014). Nell'analisi dei secoli tardo antichi, un punto nodale della ricerca di Violante era una lettera di Papa Gelasio indirizzata a Palladio episcopo (Thiel, Reference Thiel1868: 488, fr. 9), in base al quale lo storico affermava che “la vastità della Tuscia attirava secondo Gelasio le incursioni armate, probabilmente, perché pochi e radi dovevano apparirgli nella regione gli insediamenti umani e scarse, insicure, le fondazioni ecclesiastiche dipendenti d'ufficio dal vescovo. È dunque immaginabile che in tali circostanze egli avesse concreti motivi per preoccuparsi che i laici fondassero, senza controlli, oratori su proprie terre, accampassero diritti su di essi e ne facessero crescere le funzioni di culto” (Violante, Reference Violante1982: 990). Lo storico pugliese, inoltre, valorizzava un altro frammento epistolare di papa Gelasio, in cui il papa si soffermava sulla definizione delle pertinenze di basiliche ed oratori rurali, tentando di stabilire con esattezza a quali vescovi spettassero i diritti di consacrazione e, dunque, la conseguente appartenenza ad una diocesi. Secondo la lectio proposta da Violante, nell'avanzato V secolo d.C., la politica gelasiana sarebbe stata quella di abbandonare in qualche modo il ‘principio di territorialità’ in favore di “un nuovo principio, che, per stabilire a quale diocesi dovesse appartenere il nuovo oratorio, faceva riferimento alla persona da cui i fedeli del luogo erano soliti ricevere il battesimo e la cresima”.Footnote 4 L'impatto avuto dalla lectio del Violante è stato tale che, per decenni, non sono stati più avanzati contributi di sintesi sull'argomento (ad eccezione dell'importante studio di A. Fatucchi, Reference Fatucchi1990, limitato, però, soprattutto all'areale aretino): una delle spiegazioni di tale esito nell'agenda della ricerca sicuramente è da attribuire alla fisiologica necessità di tempo per assimilare pienamente un contributo così ampio e particolareggiato che, ancora oggi, si erge a punto nodale del dibattito ma, al contempo, si spiega anche con il fatto che negli anni novanta-primissimi anni duemila, si fossero avviate una serie di indagini archeologiche programmatiche in contesti chiave – basti citare gli scavi realizzati a Sant'Ippolito di Anniano (PI) (Ciampoltrini, Manfredini, Reference Ciampoltrini and Manfredini2001; Ciampoltrini, Manfredini, Reference Ciampoltrini and Manfredini2005), a San Piero a Grado (PI) (Ceccarelli Lemut, Sodi, Reference Sodi, Ceccarelli Lemut and Sodi2003; Redi, Reference Redi, Ceccarelli Lemut and Sodi2003; Redi, Reference Redi and Rotili2009), a San Pietro in Campo (LU) (Ciampoltrini, Reference Ciampoltrini2007), a San Genesio (PI) (Cantini, Salvestrini, Reference Cantini2010), a Pieve a Nievole (PT) (Ciampoltrini, Pieri, Reference Ciampoltrini and Pieri2004) alla Pieve di Pava (SI),Footnote 5 nella Pieve di San Pietro a Gropina (AR) (Gabbrielli, Reference Gabbrielli1990), solo per citare alcuni casi – che hanno consentito, finalmente, di arricchire la base dati a disposizione degli studiosi. Al IX Seminario sul tardo antico e l'alto medioevo, tenutosi a Garlate (LC) il 26–28 settembre 2002 (Brogiolo, Reference Brogiolo2003), i tempi risultarono maturi per una nuova sintesi sul territorio toscano: R. Francovich, C. Felici e F. Gabbrielli (Reference Francovich, Felici, Gabbrielli and Brogiolo2003) proposero un aggiornamento sul tema che poteva ora beneficiare di nuovi ed importanti contributi archeologici, seppur risultasse ancora fortemente debitore del modello ‘violantiano’. Sempre nel 2004 (in particolar modo, 81–88), M. Valenti dedicava parte del proprio volume sull'insediamento altomedievale nelle campagne toscane all'analisi delle emergenze ecclesiastiche di ambito rurale, arrivando alla conclusione per cui non sarebbe stata la rete del popolamento a spalmarsi su una preesistente trama ecclesiastica ma, piuttosto, il contrario (Valenti, Reference Valenti2004: 88).
Un parziale punto di svolta si ebbe con l'importantissimo seminario tenutosi nel 2006 a San Giovanni d'Asso e Montisi, significativamente intitolato Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo) (Campana, Felici, Francovich, Gabbrielli, Reference Campana, Felici, Francovich and Gabbrielli2008), in cui veniva proposta una serie di puntuali aggiornamenti su ricerche in atto e saggi di sintesi, volti a proporre da un lato considerazioni parzialmente conclusive e, dall'altro, a stimolare la ricerca futura.Footnote 6 In particolar modo risulta significativo uno dei contributi posti a sugello del volume, a firma di Richard Hodges (Reference Hodges, Campana, Felici, Francovich and Gabbrielli2008), intitolato curiosamente L'elefante nel salotto: Hodges, passando in rassegna tutti i contributi presenti nel volume, metteva in evidenza alcune tendenze che riteneva essere esplicative dell'evoluzione dei paesaggi della devozione e della cura animarum delle campagne toscane dal V al X secolo d.C. In primis, egli indicava come ci sarebbe stata una cesura nettissima tra le realtà ecclesiastiche di V-VI secolo d.C. e quelle di VIII-IX e, in secundis, come le chiese tardo antiche “furono eliminate da buona parte del territorio rurale e solo con l'assistenza dei patroni, forse sotto l'influenza o la pressione dei Carolingi, la chiesa fu una piccola struttura cellulare riaffermatasi all'interno del panorama della campagna toscana nel tardo VIII e IX secolo” (Hodges, Reference Hodges, Campana, Felici, Francovich and Gabbrielli2008: 441–42). Chris Wickham, invece, nel suo brevissimo ma incisivo intervento (2008: 445), posto subito dopo quello di Hodges, utilizzava un approccio di stampo ‘tipologico’, importante non solo ed esclusivamente per quanto concerne la puntualità del dato icnografico-architettonico ma, piuttosto, per quanto attiene i suoi risvolti storico-topografici. Lo studioso britannico sottolineava come gli edifici sorti entro il VI secolo fossero tendenzialmente di dimensioni ben maggiori rispetto a quelli seriori (con, però, le debite eccezioni, tra tutte la spettacolare chiesa di San Genesio – vicus Wallari, di fine VII-inizi VIII), probabilmente a causa della loro pertinenza ‘episcopale’ mentre, invece, ravvisava una decisa inversione di tendenza per i contesti ascrivibili alla seconda fascia tipologica, decisamente più ridotti dal punto di vista planimetrico e legati quasi sempre ad iniziativa privata.
Di grande interesse sono anche gli studi di R. Farinelli, che beneficiano di un efficace approccio ‘quantitativo’, incentrandosi prevalentemente sul periodo compreso tra VIII e X secolo d.C., ma proponendo anche chiavi interpretative legate ai secoli tardo antichi. In particolar modo, Farinelli vede una “cristianizzazione della regione […] sostanzialmente già compiuta alle soglie del conflitto Greco-Gotico, allorquando le campagne della Tuscia, assai spopolate, risultano punteggiate da un numero modesto di edifici ecclesiastici” (Farinelli, Reference Farinelli, Sánchez-Pardo and Shapland2015a: 107).Footnote 7 Un fondamentale contributo, dal punto di vista storico, è inoltre rappresentato dagli importanti e numerosi studi di M. Stoffella (Reference Stoffella2007a; Reference Stoffella and Gasparri2008; Reference Stoffella, Bougard, Goetz and Le Jan2011a; Reference Stoffella, Depreux, Bougard and Le Jan2011b; Reference Stoffella, Patzold and van Rhijn2016), incentrati sia sui ruoli svolti dalle aristocrazie longobarde e carolingie, ma anche da parte dei cosiddetti local priests, con particolare attenzione per Lucca ed il suo territorio, nonché dal pioneristico lavoro di C. Wickham (Reference Wickham1988), The Mountains and the City: The Tuscan Appennines in the Early Middle Ages, focalizzato non solo sugli aspetti legati all'ambito ecclesiastico ma, più in generale, sul territorio degli Appennini toscani tout court. Footnote 8
Una menzione meritano gli studi di Stefano Campana, Cristina Felici e del loro gruppo di ricerca, sul contesto della pieve di Pava nel senese (San Giovanni d'Asso-SI), che hanno avuto il merito di gettare un approfondito ‘sguardo archeologico’ su un territorio chiave nella celeberrima disputa tra i vescovi di Siena ed Arezzo per il possesso di numerose chiese rurali dislocate in limine tra le due diocesi, nota soprattutto dal cosiddetto “Testimoniale del 715”,Footnote 9 nonché le approfondite ricerche di Giulio Ciampoltrini nell'areale luccheseFootnote 10 e quelle di Federico Cantini nel sito di San Genesio-vicus Wallari che, da modesta realtà tardo antica assurgerà al ruolo di sito centrale nelle dinamiche insediative e della maglia ecclesiastica altomedievale (Cantini, Salvestrini Reference Cantini and Salvestrini2010).
Per quanto attiene i contesti urbani, invece, mancano quasi del tutto sintesi di ordine globale sulla formazione e successiva strutturazione di una topografia cristiana nei secoli di nostro interesse, con l'edilizia ecclesiastica quasi sempre relegata a “rumore di fondo” dei fenomeni legati alla formazione della città altomedievale. In tal senso, fanno in parte eccezione gli studi legati ad importanti scavi urbani che, però, risultano quasi sempre concentrati sul singolo monumento, come ad esempio quelli inerenti le indagini archeologiche nelle cattedrali di Firenze e LuccaFootnote 11 e, pur esulando dall'ambito territoriale di questo studio, anche quelle di Chiusi e Arezzo.Footnote 12
LE CITTÀ LE CITTÀ TOSCANE NELLA TARDA ANTICHITÀ
Prima di affrontare la questione inerente le modalità ed i tempi di formazione di quello che P. Testini (Reference Testini1986: 31–48) definì lo “spazio cristiano”, è opportuno tracciare le evoluzioni urbanistiche occorse nei principali centri della Tuscia in età tardo antica, per cogliere le correlazioni tra i tessuti insediativi preesistenti ed i nuovi poli del culto cristiano, nonché i reciproci rapporti in termini di continuità/discontinuità.
Tutti i centri urbani di maggiore importanza si andarono a sviluppare lungo le principali direttive fluviali, basti pensare a Firenze e Pisa sull'Arno e a Lucca sull’Auser/Serchio: si tratta in tutti e tre i casi di città la cui fondazione si correlò alle mire espansionistiche di Roma verso nord, nel sottofondo dello scontro con le tribù dei Ligures, per poi essere elevate, nella seconda metà del I secolo a.C., al grado di coloniae.Footnote 13
Per comprendere le trasformazioni che occorsero in queste civitates nel corso della tarda antichità bisogna partire dalla cosiddetta “crisi del III secolo”, un fenomeno che, a livello micro-territoriale, è stato forse in parte sopravvalutato, se non altro dal punto di vista delle incidenze materiali:Footnote 14 si procederà dunque, con brevi accenni alle riconfigurazioni urbanistiche che ebbero i tre principali centri della Tuscia Annonaria, ossia Lucca, Firenze e Pisa, con cenni, però, anche alle altre realtà urbane, seppur molto meno conosciute e studiate a livello archeologico, per porre le basi all'analisi dell'innesto ‘monumentale’ del Cristianesimo.
Lucca, fondata intorno al 180 a.C., dopo una stagione di grandi attività edilizie che culminò in età augustea, ebbe una fase di parziale riconfigurazione delle strutture pubbliche e private già durante il II secolo d.C. (Ciampoltrini, Reference Ciampoltrini, Bozzoli and Filieri2014: 3). Fosse di spoliazione intaccarono la domus repubblicana (I secolo a.C.) sotto Palazzo Bocella tra la fine del II e gli inizi del III secolo d.C. (Ciampoltrini, Notini, Reference Ciampoltrini and Notini1994: 56) e, a livello più generale, è possibile documentare numerosi livelli di obliterazione di edifici riferibili alla fase augustea di Luca in buona parte delle zone indagate archeologicamente (Abela, Reference Abela and Gelichi1999: 30).
Successivamente a questi stadi di recessione, a partire dalla piena età severiana Lucca attraversò un'epoca di grande rinnovamento, ben attestata anche dall'intervento di un curator rei publicae (Ciampoltrini, Reference Ciampoltrini2009: 44). L'elemento che, però, meglio certifica la nuove fase di rivitalizzazione politico-economica della città è probabilmente determinato dall'installazione, in età tetrarchica, di una fabbrica di spathae (Not. Dign., Oc., IX-29),Footnote 15 signum del volere da parte del potere centrale di investire in una politica di nuovo impulso economico, determinando non solo un importantissimo centro di produzione ‘statalizzato’, ma evidentemente anche un nuovo apparato economico e amministrativo da esso derivante.
A Pistoia, le indagini archeologiche non si attestano ad un elevato livello quantitativo e, pertanto, i depositi stratigrafici non sono noti su un'ampia estensione. Di fatto, è l'area nei pressi dell'attuale Duomo quella che ha goduto delle maggiori possibilità di indagine, già a partire dagli inizi del XX secolo (Pellegrini, Reference Pellegrini1904: 241–71), beneficiando di un'importante rilettura da parte di G. Vannini (Reference Vannini and Vannucchi1997). Lo studioso fiorentino parte dalla considerazione secondo la quale a Pistoia il momento compreso tra l'età adrianea e tutto il III secolo d.C. sarebbe stato una fase di “vero e proprio sviluppo urbanistico” (Vannini, Reference Vannini and Vannucchi1997: 44), sebbene i dati materiali non possano ritenersi sufficienti per sostenere un processo di renovatio urbana di ampio raggio. Nei primi decenni del IV secolo d.C. si venne a verificare un momento di parziale decadimento di alcune strutture, interrate da accumuli di macerie (Vannini, Reference Vannini and Vannucchi1997: 44), ma già dalla metà dello stesso IV secolo d.C. la ripresa del tessuto urbanistico sembrò rifarsi evidente. Non sembra, infatti, essere casuale che in tale torno cronologico (seconda metà del IV secolo d.C. circa) Pistoia (definita come un oppidum) fosse sede del tribunal (probabilmente itinerante) (Vannini, Reference Vannini and Vannucchi1997: 45) del corrector della Tuscia Annonaria (Amm. Marc., rer. gest., XXVII, III-1). La definizione di oppidum in taluni studi è stata attribuita ad opere di fortificazione legate alla difesa contro l'assedio di Radagaiso che, a inizi V secolo, passò in buona parte della Tuscia con le proprie truppe. In particolare, in un lavoro di F. Curti e S. Ristori (Reference Curti and Ristori1987) si registra la proposta di associare il termine oppidum alle emergenze murarie identificate nell'area del convento di San Mercuriale, realizzate quasi esclusivamente con spolia e plausibilmente ascrivibili ad una cronologia di fine IV-inizi V secolo d.C. Se, indubbiamente, la proposta dei due studiosi appaia suggestiva, bisogna forse ridimensionare la portata del passaggio di Radagaiso in Tuscia, sovente sovra-interpretato da molti studiosi ma che, in realtà, spesso non ebbe effetto alcuno dal punto di vista materiale, al punto che a Fiesole i goti non riuscirono probabilmente nemmeno ad attaccare la città da quanto erano spossati.Footnote 16
A questi pochi dati archeologici e storici risulta estremamente complesso tentare di associare elementi ascrivibili alla topografia cristiana, di fatto quasi inesistenti: la prima attestazione di un’episcopus è piuttosto tarda (492 d.C.)Footnote 17 e non esistono, ad oggi, evidenze materiali riferibili all’insula episcopalis tardo antica. Il panorama che si delinea, dunque, è molto sfuggente, il che, però, non toglie che uno sforzo di sintesi debba pur essere avanzato. Nella parcellizzazione estrema dei dati conosciuti alla ricerca, Pistoia sembra ricalcare quelle tendenze di ‘micro’ o ‘semi-micro’ territorialità che fanno della Tuscia Annonaria urbana un contesto che si svolge secondo evoluzioni topografiche e materiali pressoché analoghe nei vari centri e dove, dalla fine del IV sino al pieno VI secolo d.C., sarà il materializzarsi degli edifici di culto cristiano a ridefinire assetti ed equilibri in graduale trasformazione.
Firenze/Florentia, dedotta come colonia romana nella seconda metà del I secolo a.C.,Footnote 18 fu la capitale della Regio Tusciae et Umbriae fino almeno alla fine del IV secolo d.C. (Mirandola, Reference Mirandola and Gelichi1999: 62). Dopo grandi opere di rinnovamento edilizio verificatesi sotto l'impero di Adriano, si iniziano a documentare segnali di parziale abbandono anche in questo centro, come i dark layers rinvenuti nelle terme di San Giovanni (Maetzke, Reference Maetzke1941: 71) e l'impianto di capanne e discariche, nonché di sporadiche sepolture intra moenia già in cronologie precoci (tardo IV secolo d.C.) (Francovich, Scampoli, Cantini, Bruttini, Reference Francovich, Scampoli, Cantini and Bruttini2007: 11), ma al tempo stesso, si attestano importanti opere di restauro delle mura repubblicane. A livello generale, in questo torno cronologico le stratigrafie rivelano un evidente calo della presenza di beni ceramici di importazione, sebbene tale tendenza verrà ribaltata già nel corso del V secolo d.C., quando il vasellame proveniente da traffici a lunga distanza si andrà ad attestare all' 83,8% del totale (Francovich, Scampoli, Cantini, Bruttini, Reference Francovich, Scampoli, Cantini and Bruttini2007: 12). Le vicende della Florentia tardo antica sembrano configurarsi secondo orientamenti alterni, con da una parte segnali di destrutturazione di determinate aree (il teatro e l'anfiteatro sono dismessi o parzialmente rioccupati da capanne lignee) (Francovich, Scampoli, Cantini, Bruttini, Reference Francovich, Scampoli, Cantini and Bruttini2007: 19) e, dall'altra, chiari indizi di una rapida ripresa economica. Cionondimeno, l'elemento caratterizzante nella riconfigurazione di Firenze in epoca tardo antica ed altomedievale sarà, come in molte altre città toscane, l'impianto degli edifici di culto cristiano, come vedremo nel paragrafo successivo.
Per quanto concerne Pisa, i dati archeologici sono meno numerosi ed i problemi di definizione delle evoluzioni diacroniche del centro insorgono già a partire dall'età romana, dal momento che la planimetria e l'estensione dello spazio cinto dalle mura (di fatto, sconosciute per tale fase) sono ampiamente indefiniti ed indefinibili (Fabiani, Ghizzani Marcìa, Gualandi: 169). È ad ogni modo noto come Pisa divenne municipium intorno all'88 a.C., per essere successivamente dedotta come colonia tra il 42 ed il 27 a.C., con il nome di Colonia Opsequens Iulia (Fabiani, Ghizzani Marcìa, Gualandi, Reference Fabiani, Ghizzani Marcìa, Gualandi, Anichini, Dubbini, Fabiani, Gattiglia and Gualandi2013: 172). Come già sottolineato, i dati materiali inerenti l'età repubblicana ed imperiale non sono sufficienti a definire la reale estensione della colonia e le sue peculiarità, sebbene due testimonianze epigrafiche, i cosiddetti decreta pisana (CIL XI, 1420, 1421), costituiscano un significativo elemento per il discernimento di una seppur minima parte della topografia classica di Pisa. Nonostante ciò, importanti scavi realizzati nell'area circostante il Duomo hanno fornito rilevanti dati pertinenti ad una serie di domus databili tra l'età augustea ed il II secolo d.C. (Fabiani, Ghizzani Marcìa, Gualandi, Reference Fabiani, Ghizzani Marcìa, Gualandi, Anichini, Dubbini, Fabiani, Gattiglia and Gualandi2013: 173), più tardi riutilizzate, in seguito ad un parziale abbandono, per la messa in opera di capanne in armatura di pali lignei nel corso del V-VI secolo d.C. (Alberti, Paribeni, Reference Alberti and Paribeni2006), nonché per l'impianto di una necropoli (Alberti Reference Alberti, Alberti and Paribeni2011: 205–06). Inoltre, nel III e IV secolo d.C., altre importanti aree funerarie andarono ad insistere nel suburbium, come l'importante cimitero scoperto nell'attuale Via Marche (Paribeni, Cerato, Rizzitelli, Mileti, Sarti, Reference Paribeni, Cerato, Rizzitelli, Mileti and Sarti2006). Quanto è possibile osservare nell'evoluzione urbana di Pisa durante la tarda antichità è che la città sembrò comunque garantire un buon grado di continuità dei propri assetti, a parziale di differenza ad esempio di Lucca che, proprio nel tardo II secolo d.C., fu attraversata da alcuni decenni di recessione, seppur ampiamente sorpassati nel III secolo d.C. (vedi supra).
A Fiesole, le cui origini risalgono perlomeno all'Età del Ferro, le mura difensive vennero edificate intorno al III secolo a.C., sebbene il momento di maggior crescita si debba probabilmente registrare in epoca sillana (Favilla, Reference Favilla and Gelichi1999: 47–48). Come a Siena, il primigenio sistema insediativo di Fiesole si articolò probabilmente in due poli distaccati, i cui setti viari sono parzialmente ancora rintracciabili nell'orientamento di quelli attuali, in una prospettiva di straordinaria persistenza topografica (Favilla, Reference Favilla and Gelichi1999: 48). Un notevole numero di edifici pubblici occupò Fiesole in epoca romana, come il Capitolium, il foro e almeno due importanti impianti termali: è molto importante sottolineare il fatto che entrambi ebbero una lunga continuità d'uso, in un caso fino alla fine del V secolo d.C. (scavo di Via Garibaldi). Proprio in tale frangente, però, vennero entrambi abbandonati e riconvertiti in aree funerarie: in particolar modo tale fenomeno interessò le terme situate nella cosiddetta “Area archeologica” già dall'inizio del V secolo d.C., un evento che alcuni studiosi riconnettono direttamente all'assedio di Radagaiso, cui Fiesole fu sottoposta nel 406 d.C. (Proc., Bellum Gothicum II, 23–24; 27). Tale chiave di lettura potrebbe essere plausibile, sebbene la diretta dipendenza tra eventi ‘catastrofici’ ed i depositi archeologici sia da affrontare sempre con estrema prudenza: in ogni caso tale esegesi potrebbe in effetti confermare la natura episodica ed occasionale della presenza di sepolture intra urbem in cronologie così precoci.Footnote 19
Ultimo caso significativo è rappresentato dalla città di Volterra. Essa vanta origini tracciabili indietro nel tempo sino all'epoca etrusca, con uno straordinario sviluppo nel IV e III secolo a.C., quando importanti templi vennero edificati sull'acropoli ed utilizzati perlomeno sino alla fine del III secolo d.C. Il centro etrusco era difeso da imponenti mura che descrivevano una superficie che in epoca romana verrà sensibilmente ridotta, corrispondendo grossomodo all'estensione dell'attuale centro storico (Alberti, Reference Alberti and Gelichi1999: 75). Fenomeni di parziale metamorfosi della facies romana volterrana si iniziarono a verificare a partire dal III secolo d.C., con crolli documentati nelle terme pubbliche (Munzi, Ricci, Serlorenzi, Reference Munzi, Ricci and Serlorenzi1994: 614) e accumuli di livelli di discarica in altre strutture ad uso collettivo, che sembrano testimoniare un profondo collasso della città ‘classica’ che durò sino al IV-V secolo d.C. e, in determinati casi, fino almeno al VI (Alberti, Reference Alberti and Gelichi1999: 79).
LA CRISTIANIZZAZIONE DEGLI SPAZI URBANI
Partendo dall'analisi delle fonti scritte, è inevitabile doversi confrontare in primis con le prime attestazioni di vescovi con attendibilità storica tracciabili nei documenti e con il tentativo di comparare tali informazioni con le tracce materiali lasciate dal cristianesimo (Fig. 02): a Lucca il primo vescovo attestato storicamente dalla documentazione scritta è Maximus, presente al concilio di Serdica del 343 d.C.Footnote 20 Firenze, con Felix, e Pisa, con Gaudentius, certificano in entrambi i casi le attestazioni dei primi vescovi al 313 d.C.,Footnote 21 mentre sia Fiesole che Volterra rimandano le origini dei propri sogli episcopali al 496 d.C.;Footnote 22 infine, a Pistoia si testimonia un primo episcopus anonimo tra il 492 ed il 496 d.C.Footnote 23

Fig. 2. Tavola sinottica con i centri diocesani, le prime attestazioni episcopali e le prime testimonianze materiali delle ecclesiae episcopales (elaborazione dell'a.).
Analizzando le emergenze monumentali delle principali città, è possibile documentare come modalità e tempistiche del cristianesimo furono invero differenti. Ad Arezzo, i resti archeologici della prima ecclesia episcopalis, sebbene di lettura non semplice, hanno una cronologia compresa tra la seconda metà del VII secolo d.C. e l'840 d.C., quantunque la presenza di sepolture databili tra il IV ed il VI secolo d.C., identificate sul colle del Pionta, potrebbero testimoniare indirettamente una sussistenza più antica della chiesa vescovile.Footnote 24 A Luni l’ecclesia episcopalis data il proprio impianto incipitario al tardo IV-inizi V secolo d.C.,Footnote 25 mentre a Pisa la prima menzione scritta del complesso episcopale risale al 748 d.C. (CDL, I, n. 93), anche se i resti di un battistero (forse databili al VI secolo d.C.) sembrerebbero rimandare ad una coeva fondazione dell’ecclesia (Pani Ermini, Stiaffini, Reference Pani Ermini and Stiaffini1985). A Pistoia si deve invece far fronte ad una considerevole carenza di dati, che non ci autorizza ad identificare le tracce della cattedrale tardo antica (Giannini, Reference Giannini2006); per quanto concerne Siena, nonostante la prima attestazione di un vescovo (Eusebius) nel 465 d.C.,Footnote 26 un emiciclo – visibile però solamente nel suo prospetto esterno – non sembra sufficiente da solo a certificare la presenza monumentale di un’ecclesia episcopalis nella seconda metà del V secolo d.C.Footnote 27
Dati materiali ben più tangibili si hanno, invece, per i complessi episcopali di Luni, Lucca e Firenze: a Luni, esso sorse all'interno della cosiddetta ‘cittadella’, nel comparto sud-occidentale dello spazio urbano. Dell’insula episcopalis, oltre alla fortificazione, non sono noti né l'episcopio né il battistero, ma solamente l’ecclesia: essa si imposta al di sopra della domus detta ‘di Oceano’, alla fine del V secolo d.C. (Lusuardi Siena, Reference Lusuardi Siena and Marcenaro2003), plausibilmente in concomitanza con la prima attestazione di un vescovo nella cronotassi, quel Felix che viene citato nei sinodi romani del 465 e del 466 d.C. promossi da papa Ilaro (461–468 d.C.).Footnote 28 Il primo impianto (che secondo S. Lusuardi Siena poteva essere dedicato al Salvatore) è caratterizzato da un'aula a tre navate, con abside semicircolare piuttosto profonda e divisione presbiteriale a circa metà della navata centrale, divisa dalle navatelle laterali da colonnati realizzati prevalentemente con materiali di reimpiego, tra cui si segnalano alcune basi onorarie, provenienti con ogni probabilità dall'area capitolina.
A Lucca, il primo impianto dell’ecclesia episcopalis si inquadra nel tardo IV secolo-inizi del V, nel comparto sud-orientale della città, sui resti di un precedente contesto residenziale.Footnote 29 La dedica (a Santa Reparata) dell'edificio si attesta per la prima volta nel 754 d.C. (MD/IV, I-114), mentre nell'881 d.C. è citata (MD/V, II-906) come eccl. S. Johann. Baptiste sita infra hanc Lucanam civitatem (bisogna però rilevare come almeno dal 724 d.C. il rango di ecclesia episcopalis fosse passato alla vicina chiesa di San Martino, che in tale anno viene menzionata come eccl. S. Martini in episcopio) (MD/IV, I-35). Le emergenze monumentali degli scavi nel complessoFootnote 30 hanno restituito una grande aula absidata, articolata in tre navate, con pregiato pavimento musivo, attribuita ad una cronologia di fine IV-inizi V secolo d.C. (Quiròs Castillo, Reference Quiròs Castillo2001: 36).
Per quanto concerne Firenze, chi scrive, con R. Farioli Campanati (Reference Farioli Campanati1975), tende ad identificare il primo complesso episcopale con la chiesa di Santa Reparata, identificata al di sotto dell'attuale duomo di Santa Maria del Fiore (Toker, Reference Toker1975; Reference Toker2013). Tale esegesi si pone in netta controtendenza con la lectio dominante nella letteratura, che, invece, propone di riconoscere la collocazione topografica della prima ecclesia episcopalis fiorentina presso San Lorenzo, nell'immediato suburbio settentrionale.Footnote 31 Il ‘legame’ tra i due siti (e la conseguente diatriba interpretativa) si deve soprattutto alla figura del vescovo Zanobi/Zenobius, citato da Paolino di Milano (biografo di Sant'Ambrogio) nella sua Vita Ambrosii,Footnote 32 agli inizi del V secolo d.C. Lo stesso Ambrogio, sempre in base a quanto ci tramanda Paolino, fu invitatus a Florentinis ad Tusciam,Footnote 33 dove constituit proprio la chiesa di San Lorenzo a Firenze nel 394 d.C.,Footnote 34 in cui depose le reliquie del santo Agricola, successivamente all’inventio bolognese.Footnote 35 In base a questi dati, dunque, numerosi studiosi hanno, per automatica associazione di idee, ritenuto di considerare la basilica di San Lorenzo – definita anche Basilica Ambrosiana per evidenti motiviFootnote 36 – la prima ecclesia episcopalis fiorentina. È però molto probabile che alcuni di essi siano stati fuorviati principalmente da due Vitae Zanobii di epoca medievale, la prima redatta dall'arcivescovo di AmalfiFootnote 37 nella prima metà dell'XI secolo d.C. e la seconda dallo Pseudo-Simpliciano (Vita Zanobii auctore Simpliciano), testo apocrifo trasmesso in un codice di XII secolo d.C. In entrambe le leggende agiografiche si dice che Zanobi sarebbe stato sepolto proprio in San Lorenzo, dopo il decesso avvenuto nel 397 d.C. e che, pochi anni dopo, le sue spoglie sarebbero state traslate nell’ecclesia dedicata a Santa Reparata.Footnote 38 Evidentemente l'interpretazione di questi due testi risulta, dal punto di vista metodologico, estremamente perigliosa, dal momento che ingenera differenti problematiche esegetiche: in primis è sempre importante sottolineare come sia da evitare rigorosamente la pratica di utilizzare le fonti scritte in maniera retroattiva e, in secundis, è opportuno rimarcare come è probabile che proprio l'ipotesi di un'originaria sepoltura del vescovo Zanobi a San Lorenzo abbia ingenerato il τόπος storiografico di una primigenia dignità di ecclesia episcopalis di tale basilica e, allo stesso modo, la sua traslazione nell’ecclesia mater abbia fatto ritenere che solo in un secondo momento proprio Santa Reparata sarebbe diventata la chiesa madre di Firenze. Inoltre, le indagini archeologiche nel contesto di San Lorenzo non hanno apportato alcuna evidenza materiale ascrivibile ad un edificio ecclesiastico, ma solamente tracce di preesistenze di età romana e di una piccola area funeraria che, forse, potrebbe essere l'unico legame con un santuario cristiano, pur piuttosto labile (Maetzke, Reference Maetzke and Poggetto1977). Al contrario, invece, le indagini di F. Toker al di sotto di Santa Maria del Fiore hanno restituito le vestigia di un grande edificio basilicale, a tre navate, con un pregiato pavimento musivo, databile a fine IV-inizi V secolo d.C. (sebbene le più recenti analisi al C14 propendano per alzarne la cronologia al VI) (Toker, Reference Toker2013), impostato su una domus di età imperiale, dismessa alla metà del IV secolo d.C. (Toker, Reference Toker1975), tutti elementi che concorrono, in dialogo con le fonti sopra discusse, a corroborarne l'attribuzione alla primigenia ecclesia episcopalis della Florentia tardo antica.
Da questo raffronto cronologico emergono chiaramente differenti sviluppi storici ed archeologici, per cui risulta evidente come si debbano considerare con forte spirito critico equilibri spesso profondamente eterogenei tra i differenti bacini di fonti a nostra disposizione, un aspetto che può dipendere da vari elementi: da un lato si deve spesso affrontare una scarsezza di documenti scritti, che potrebbero essersi in parte persi, come evidente, nel corso dei secoli, ma dall'altro lato il problema è più complesso, in quanto la presenza di un vescovo, specialmente nei primi momenti di configurazione e consolidamento del cristianesimo, non andava ad implicare autonomamente la presenza di un’ecclesia episcopalis monumentale.Footnote 39
Per riassumere brevemente, dunque, ciò che si può evincere dalla rassegna di dati appena proposta è che gli assetti monumentali del cristianesimo riconfigurarono profondamente le trame urbane di stampo ancora ‘romano’ tra la fine del IV ed il VI secolo d.C., creando nuovi poli antropici (Christie, Reference Christie2006: 206): le gerarchie spaziali delle coloniae e dei municipia di epoca ‘classica’ non sussistevano più in quanto tali e, in stretta relazione con questo aspetto, le mura difensive non sembrano essere più un elemento distintivo e dirimente nella lettura degli spazi cittadini, che iniziarono a compenetrarsi con quelli dei suburbia, dove le chiese divengono “fattori complessi di aggregazione” (Cantino Wataghin, Gurt Esparraguera, Guyon, Reference Cantino Wataghin, Gurt Esparraguera, Guyon and Brogiolo1996: 17) (Fig. 03).

Fig. 3. Le principali città della Tuscia Annonaria con in evidenza le collocazioni topografiche delle ecclesiae episcopales tardo antiche (elaborazione dell'a.).
LE CITTÀ DELLA TUSCIA ANNONARIA NELL'ALTO MEDIOEVO
Le profonde metamorfosi che caratterizzarono l'urbanesimo tardo antico ebbero, in molti casi, una continuità spaziale e ‘concettuale’ che interessò anche tutto l'arco dell'alto medioevo.
Se fino al V secolo d.C. è possibile documentare sia la presenza di edifici privati in tecnica edilizia ancora di buona qualità e la continuità d'uso di alcuni spazi pubblici (come le terme di Fiesole, già citate, o quelle di Siena, realizzate tra la fine del IV e gli inizi del V secolo d.C.) (Cantini, Citter, Reference Cantini2010: 409), dal V secolo d.C. in avanti si inizia a testimoniare l'introduzione più ingente di unità abitative in materiali ‘poveri’, come legno e argilla, sebbene in taluni casi esse convivessero con tipologie edificatorie ancora realizzate in muratura.Footnote 40
A Pisa, dove il foro fu utilizzato secondo la propria destinazione originaria (dunque, evidentemente, di spazio pubblico) fino almeno al V secolo d.C., come testimoniato anche da Rutilio Namaziano (De reditu I, 575), capanne lignee (denunciate da buchi per palo e focolari) andarono ad intaccare i piani d'uso di domus databili all'età imperiale, ormai parzialmente crollate (Alberti, Paribeni, Reference Alberti and Paribeni2006: 211–13). A Fiesole, un grande edificio pubblico fu parcellizzato in piccoli ambienti con muretti di scarsa qualità, le cui tracce di frequentazione antropica sono ben leggibili anche in piani di calpestio in terra battuta e in focolari (Rastrelli, Reference Rastrelli2006). A Firenze, livelli di discarica obliterarono i resti di una domus di epoca romana, e, a loro volta, vennero riutilizzati come base su cui impostare capanne lignee in fasi ormai già altomedievali (Cantini et al., Reference Cantini, Cianferoni, Francovich and Scampoli2007: 253–57).
Lucca è probabilmente la città sui cui secoli altomedievali abbiamo il maggior numero di informazioni, anche grazie allo straordinario apporto fornito dalle fonti scritte e, pertanto, necessità di un maggior grado di approfondimento: un documento proveniente dall'Archivio Arcivescovile menziona al 684 d.C. la prima attestazione certa di una ‘presenza’ longobarda in città (De Conno, Reference De Conno and Rossetti1991: 59). Come ci insegna Paolo Diacono (Hist. Lang., II, 26) (la cui reale attendibilità storica però, come noto, deve essere sempre valutata con prudenza) i Longobardi si affacciarono in Lucchesia dopo aver attraversato i valichi tra Liguria e Toscana, entrando nell'attuale Garfagnana. A testimonianza di ciò, in tale area sopravvivono ancora adesso toponimi la cui origine è marcatamente longobarda, denunciando la strutturazione di un sistema insediativo che presto si sarebbe ancorato anche in realtà rurali (Ciampoltrini, Reference Ciampoltrini2007: 19): vico Alahis, vico Elingo, vico Schulcamo, vico Gulfari, vico Turingo e vico Gundualdi ne sono evidenti esempi. All'interno dello spazio urbano e nell'immediato suburbium, i rinvenimenti di sepolture come quelle identificate in Via Buia (Ciampoltrini, Reference Ciampoltrini2007: 61) e in Piazza del Suffragio (Ciampoltrini, Reference Ciampoltrini2007: 19) sono ulteriori signa di presenze a carattere alloctono, che stigmatizzano un probabile stanziamento longobardo antecedente al 684 d.C., considerando anche il fatto che il trattato di pace stipulato a Bagnoregio nel 605 d.C. divise la Tuscia in Tuscia Romanorum e in Tuscia Langobardorum (P. Diac., Hist. Lang., IV, 32), con quest'ultima avente Lucca come sede di ducato, analogamente (o quasi) a quanto avvenne a Chiusi e Firenze. Diviene dunque inevitabile interrogarsi sull'impatto topografico che ebbe l'arrivo dei nuovi regnanti, un aspetto che con il solo ausilio dei dati archeologici sarebbe, però, di difficile tracciabilità. Infatti, gli scavi intra urbem non hanno rivelato tracce consistenti di unità insediative afferenti al VII e VIII secolo d.C.: tra le poche note si menzionano quelle relative alle buche per pali e ai battuti di terra identificati al di sotto di Palazzo Lippi (Ciampoltrini, Notini, Reference Ciampoltrini and Notini1990: 571) e, probabilmente, i depositi sottostanti l'attuale Via San Giorgio e Via Cesare Battisti (Ciampoltrini, Reference Ciampoltrini2011: 30). Indizi di ulteriori capanne a destinazione privata-abitativa provengono dal Cortile Carrara (Ciampoltrini, Reference Ciampoltrini2011: 46) e da Via San Paolino (Ciampoltrini, Reference Ciampoltrini2011: 30–34), tutte riconducibili a cronologie di VII-VIII secolo d.C., come ben dimostrato dai reperti ceramici. A questo punto è fondamentale confrontare il dato materiale con quello proveniente dalle fonti scritte, molto ricche per quanto concerne le strutture private. I documenti d'archivio, infatti, testimoniano tra il VII e l'VIII secolo d.C. la presenza di almeno 37 case in muratura, sovente provviste di giardini/orti privati, definiti come curte o curticella (Belli Barsali, Reference Belli Barsali1973). Queste orbitavano intorno a zone che si configuravano come centri di espressione dei maggiori gradi delle gerarchie urbane, come l’episcopium e la curtis regia; inoltre, esse erano ‘incorniciate’ da un elevato numero di chiese che, secondo le fonti scritte, erano nel corso del VII secolo d.C. 24 all'interno del profilo delle mura e 14 nell'immediato suburbium (Abela, Reference Abela and Gelichi1999: 39). Appare di conseguenza discutibile proporre un modello di una città altomedievale ‘frammentata’ se si vanno a leggere tali dati che, invece, sembrano rivelare una densità insediativa piuttosto consistente: la stessa presenza di strutture come curte e curticella non deve essere letta come un segno di abbandono degli spazi urbani ma, piuttosto, come “parte integrante del fatto edilizio ed urbanistico” (Belli Barsali, Reference Belli Barsali1973: 488). In parte contrario al modello della ‘città a isole’ è anche C. Wickham (Reference Wickham2009: 708), che sottolinea da un lato come “l'Italia è anche la regione in cui l'archeologia mostra più chiaramente una generalizzata sopravvivenza dell'urbanesimo” e che, discutendo questo stesso modello, afferma come in realtà si debba considerare anche un paradigma ‘alternativo’, che è “una versione più concentrata di quello precedente [quello “a isole” - n.d.a.], in cui le nuove chiese e gli altri monumenti erano più vicini tra loro (formando talvolta un nuovo centro cittadino)” (Wickham, Reference Wickham2009: 706).
Nel tentativo di descrivere le metamorfosi delle città altomedievale della Toscana settentrionale è però necessario un ulteriore affondo sulla topografia cristiana, soprattutto nel raffronto tra la gestione delle risorse e le prospettive delle committenze in età longobarda, con alcuni accenni anche all'età carolingia. Osservando le fondazioni di edifici ecclesiastici che si verificarono nel VII e nell'VIII secolo d.C. (Farinelli et al. Reference Farinelli, Corti, Marchese, Sànchez Pardo, Campana, Felici, Francovich and Gabbrielli2008: tab. 17) (Fig. 04), appare evidente come le élites longobarde avessero investito principalmente nelle infrastrutture religiose, probabilmente in quanto queste costituivano uno dei principali veicoli di rappresentazione del proprio status, anche in virtù del fatto che le aristocrazie fossero, in tale contorno cronologico, stanziate principalmente in ambito urbano (Gasparri, Reference Gasparri2012). Sembra invece che, una volta che la transizione al dominato carolingio fu completata, le élites avessero preferito concentrare i propri investimenti nelle aree rurali (Valenti, Reference Valenti and Gasparri2008) (come enunciato dalla fondazione di numerosi monasteri extra urbem (Valenti, Reference Valenti and Gasparri2008: 227–28), le cui funzioni risultavano sempre più legate anche ad esigenze fiscali e giuridiche) (Azzara Reference Azzara and Rocca2002), anche se ciò non escluse importanti interventi all'interno dello spazio cittadino, con significative (e talora massive) opere di restauro delle chiese.

Fig. 4. Dati quantitativi inerenti le fondazioni di edifici di culto cristiano in ambito urbano (elaborazione dell'a.).
Un aspetto rilevante delle evoluzioni urbane altomedievali è inoltre tracciabile nella persistenza di determinati bacini topografici che si configurarono già nei secoli tardo antichi: a Lucca, di nuovo, nel luogo in cui dalla fine del IV secolo d.C. venne edificata l’ecclesia episcopalis (parte sud-occidentale della città, ove tale impresa andò, de facto, a determinare la formazione di un nuovo gruppo di potere), ancora nel pieno alto medioevo, insistevano gli edifici legati alle più alte gerarchie, sia ecclesiastiche che laiche. Infatti, anche se il rango di cattedrale venne traslato alla chiesa di San Martino almeno dal 724 d.C. (CDL/I: n. 113), nel corso dell'VIII e del IX secolo d.C. S. Reparata era ancora una delle più importanti e venerate chiese della città, con l’episcopium e la curtis regia che continuavano ad insistere nella medesima area cittadina. In particolar modo, la vicinanza tra la prima ecclesia episcopalis e la curtis regia creava un vero e proprio ‘asse’ ideale (ma anche fisico-topografico) tra il potere spirituale e quello temporale, che durò dalla tarda antichità fino al traguardo dell'alto medioevo (Castiglia, Reference Castiglia2016) (Fig. 05). Tale aspetto può parzialmente essere letto anche in altri contesti urbani del territorio di nostro interesse, anche se, sfortunatamente, disponiamo di una documentazione più carente: i luoghi di fondazione delle ecclesiae episcopales, dove nel tardo medio evo sorgeranno le cattedrali pre-romaniche e romaniche, mostrano ancora una volta la longue durée funzionale-ideologica di determinati assetti topografici. Questo fenomeno è ben testimoniato a Firenze (Toker, Reference Toker1975), Lucca (Piancastelli Politi Nencini, Reference Piancastelli Politi Nencini1992), probabilmente a Pisa (Alberti, Baldassarri, Gattiglia, Reference Alberti, Baldassarri, Gattiglia and Baldassarri2006), Chiusi (Martini, Reference Martini1997: 75) e Siena (Cantini, Reference Cantini and Gabbrielli2011: 40–44; Castiglia, Reference Castiglia2014: 9–12, 119–20) (anche se, specificamente per Siena, i dati sono del tutto insufficienti). In quest'ottica, però, rimane di difficile soluzione la questione inerente lo spostamento del rango di ecclesia episcopalis, a Lucca, da Santa Reparata a San Martino, anche alla luce della sostanziale assenza di dati archeologici di epoca alto medievale per quanto attiene la ‘nuova’ cattedrale. Un'ipotesi, per quanto allo stato attuale non corroborata da fonti sostanziali (né scritte né materiali), potrebbe essere quella della volontà da parte delle élites di voler consacrare un nuovo edificio preposto al soglio episcopale legato alla figura di San Martino che, come noto, era uno dei santi maggiormente venerati in epoca longobarda.Footnote 41 Del resto, tale scelta ben collimerebbe anche con il ruolo politico che Lucca svolgeva, cioè quello di sede ducale, che implicava anche una valenza di ‘rappresentanza’, in cui la realizzazione di un nuovo grande cantiere vescovile dedicato a San Martino si sarebbe potuta imporre come ulteriore signum della volontà auto-rappresentativa ed identitaria delle aristocrazie, lato sensu. A margine, inoltre, è importante sottolineare come tale fenomeno di ‘traslazione’ del ruolo di chiesa episcopale nei secoli altomedievali non si verifichi nelle altre città considerate in questa ricerca (con il dubbio caso di Firenze, già discusso, che però, da un lato, è in buona parte indimostrabile e, dall'altro, rimanderebbe comunque ancora ad età tardo antica), il che sembrerebbe avvalorare ulteriormente la valenza in qualche modo ‘simbolica’ di una scelta programmatica legata alla più importante sede ducale della regione.Footnote 42

Fig. 5. Lucca nell'altomedioevo: si vuole far notare la continuità topografica determinata dalla creazione del complesso episcopale nel comparto sud-orientale della città nell'alto medioevo, ove si struttureranno anche la curtis regia (CR) e la zecca (Z) (elaborazione dell'a.).
LE CAMPAGNE LA TUSCIA ANNONARIA RURALE NEL PANORAMA TARDO ANTICO
Nell'ambito cronologico dei secoli di formazione dei paesaggi post romani, il territorio corrispondente all'attuale Toscana sembra configurarsi come zona ‘liminale’, in cui non arrivarono mai a piena e completa espressione gli elementi che, in Italia meridionale in un modo e in quella settentrionale in un altro, potrebbero definirsi ‘caratterizzanti’ delle campagne tardo antiche. Tale aspetto è ben tratteggiato in una recente sintesi (Valenti, Reference Valenti, Delogu and Gasparri2010), in cui si evidenzia come se da un lato, nell'Italia del sud, il sistema economico ruotasse prevalentemente intorno alle grandi proprietà latifondistiche, sia fiscali che senatorie e, dall'altro, nell'Italia del nord, fosse configurato attorno alla riconversione di numerose ville in officine produttive, alla formazione di grandi residenze lussuose e, in numerosi casi, alla strutturazione del sistema dei castra, in Toscana nessuno di questi due modelli arrivò mai ad una completa definizione. Fatto salvo per alcuni limitati casi ‘eccezionali’, come ad esempio la villa di San Vincenzino presso Cecina in provincia di Livorno (Donati, Reference Donati2013), ove nel corso del IV secolo d.C. si documentano significativi investimenti che implicarono importanti ristrutturazioni sia della zona residenziale che degli impianti produttivi, o la villa di Massarosa (Anichini, Reference Anichini2012), in Lucchesia, o ancora la Villa dell'oratorio a Capraia e Limite (FI) (Cantini, Reference Cantini2013), nella Tuscia Annonaria le grandi proprietà rurali tardo antiche sembrano attestarsi ad un livello quantitativo piuttosto basso. I modelli demici dei secoli immediatamente post classici, invece, appaiono essere organizzati prevalentemente secondo una progressiva rarefazione dei sistemi insediativi (Valenti, Reference Valenti, Delogu and Gasparri2010: 523–24), ben tradotti nell'alto tasso percentuale di abbandono delle ville,Footnote 43 nello stanziamento di case sparse in materiali misti e nella parziale sopravvivenza dei nuclei commerciali/produttivi attestati lungo le principali vie di comunicazione. Secondo tale ottica, emerge nuovamente quanto già tratteggiato per la Toscana delle città, in cui si evidenziano differenze piuttosto marcate tra l'ambito annonario e quello suburbicario (Cantini, Citter, Reference Cantini, Citter, Delogu and Gasparri2010), ove la parte settentrionale (Tuscia Annonaria) garantisce evidenze di maggior continuità e tenuta dei bacini economico insediativi. In particolar modo, è la rete fluviale che sembra potersi caratterizzare come elemento dirimente in tal senso, con il fiume Arno in particolar modo, ma anche, in parte, con l’Auser/Serchio nella Lucchesia, che costituiscono i principali vettori di una ‘tenuta’ sia insediativa che economica. Non sono infatti solamente le principali città della Tuscia Annonaria che vanno ad orbitare nei pressi dei grandi bacini fluviali (Firenze, Lucca, Pisa e anche la più piccola Empoli), ma anche importanti insediamenti di carattere secondario, come ad esempio San Pietro a Grado (Redi, Reference Redi, Ceccarelli Lemut and Sodi2003; Sodi, Reference Sodi, Ceccarelli Lemut and Sodi2003) o San Genesio (Cantini, Salvestrini Reference Cantini and Salvestrini2010). Non solo, contesti portuali come il Portus Pisanus o Vada Volaterrana sono il terminale di traffici commerciali ancora ampiamente attivi almeno fino al V-VI secolo d.C., come ben testimoniato dalle tipologie ceramiche attestate in tutto il Valdarno (Cantini, Reference Cantini2010; Reference Cantini, Cirelli, Diosono and Patterson2015), ed indicano come in effetti si possa leggere proprio nel fiume Arno e nei territori immediatamente a sud di esso il più probabile limite di confine tra le due Tusciae.
LA FORMAZIONE DELLA TOPOGRAFIA CRISTIANA RURALE DELLA TUSCIA ANNONARIA DALL'EPOCA TARDO-ANTICA FINO ALLE SOGLIE DELL'ETÀ LONGOBARDA
In che modo, dunque, si andò ad inserire la ‘materialità’ del cristianesimo in questa rete insediativo-economica? Guardando semplicemente alle piante proposte per il V ed il VI secolo d.C. (Fig. 6), sembra che la trama degli edifici cristiani attestati nel territorio rurale della Tuscia Annonaria risulti piuttosto evanescente: abbiamo già visto come dalla fine del IV, fino al VI secolo d.C., la maggior parte delle chiese fosse fondata in ambito urbano, mentre proprio in questo torno cronologico nelle campagne la tendenza sembrerebbe risultare opposta.Footnote 44 Partendo dalla lectio di Cinzio Violante (Reference Violante1982: 990), poi ripresa in più sedi – con maggior consapevolezza e spirito critico – da Mauro Ronzani (Reference Ronzani2009; Reference Ronzani2014), la Tuscia, all'epoca di papa Gelasio (492–96 d.C.), fino almeno a papa Pelagio (556–61 d.C.), sembrerebbe caratterizzata in ambito rurale da una ‘geografia ecclesiastica’ molto debole, quasi indefinibile, con pochi edifici dedicati alla cura animarum e, di conseguenza, sussisterebbe la mancanza di una vera e propria ‘rete’ clericale. La carenza di progetti di scavo di ampio respiro incentrati su tali tematiche, inoltre, implica non solo una scarsa conoscenza quantitativa degli edifici di culto cristiano tardo antichi, ma ne compromette anche il valore ‘qualitativo’, ossia il discernimento dei loro rapporti con gli insediamenti, sebbene, come vedremo di seguito, non manchino casi di segno opposto, che vanno a costituire il primo ‘campanello di allarme’ per iniziare a rivalutare determinate tendenze interpretative.
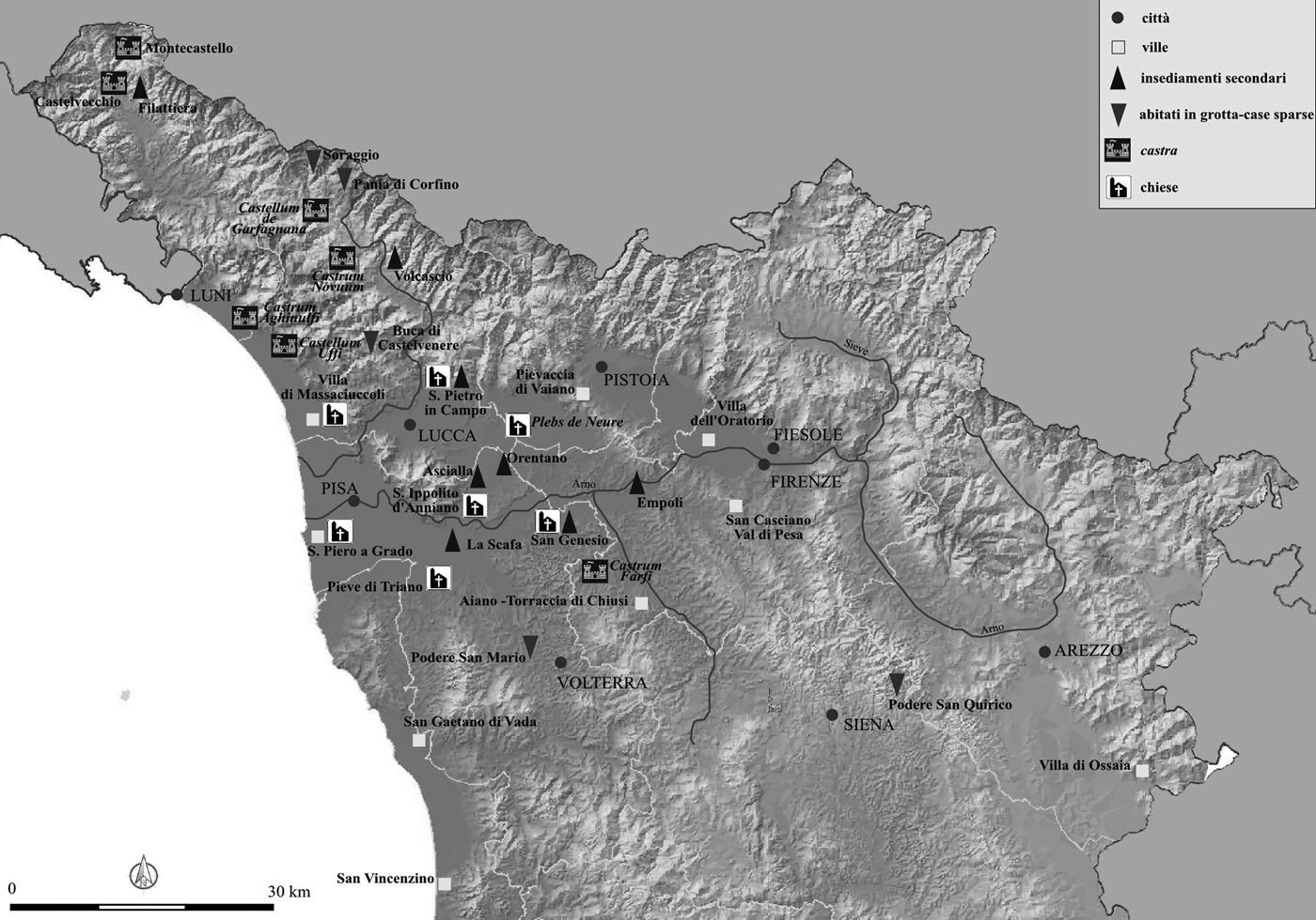
Fig. 6. Pianta con in evidenza le chiese rurali ascrivibili al V-VI secolo d.C. nel territorio sotto indagine, in relazione alle evidenze insediative (elaborazione dell'a.).
A Sant'Ippolito di Anniano (Santa Maria a Monte - PI), sui resti di una probabile fattoria di epoca alto imperiale, alla fine del IV secolo viene fondato un edificio interpretato dagli scavatori come oratorio privato o μαρτύριον.Footnote 45 Nel pieno V secolo d.C. la struttura venne ampliata e riconvertita in chiesa mono-nave, subendo un ulteriore rifacimento ed ingrandimento nel corso del VI, quando diventò un grande edificio a tre navate, con battistero addossato sul lato meridionale (Ciampoltrini, Manfredini, Reference Ciampoltrini and Manfredini2001; Reference Ciampoltrini and Manfredini2005).
A San Piero a Grado (Redi, Reference Redi1986; Reference Redi, Ceccarelli Lemut and Sodi2003), a pochi km da Pisa (in corrispondenza dell'antica linea di costa), sui resti di una probabile villa di prima epoca imperiale (molto probabilmente legata ad uno scalo portuale), nel V secolo d.C. venne edificata una grande chiesa a tre navate (di dimensioni eccezionali, quasi ‘urbane’), probabilmente in relazione alla tradizione leggendaria (ed, evidentemente, del tutto inattendibile) per cui qui sarebbe sbarcato San Pietro per evangelizzare il territorio pisano.
A San Genesio, presso San Miniato (PI), nel luogo in cui sorgeva un indefinito “edificio romano”, poi dismesso, nel V secolo d.C. si forma un esteso cimitero, orbitante intorno ad un piccolo mausoleo (o torre) che, tra VI e VII secolo d.C., venne riconvertito in una chiesa orbitante evitare ripetizione attorno ad un insediamento caratterizzato da case in materiali misti e/o deperibili (Cantini, Reference Cantini, Campana, Felici, Francovich and Gabbrielli2008).
In questi siti, tra i più significativi e meglio noti, gli edifici di culto ebbero, con fisiologiche trasformazioni e rifacimenti, una straordinaria continuità fino alla fine dell'alto medioevo. In tutti i casi sembrerebbe trattarsi di contesti che sorsero nell'ambito di insediamenti secondari o ville, sebbene la mancata indagine in open area delle stratigrafie esterne agli edifici di culto (fatta eccezione per San Genesio) comprometta in parte la completezza di tali letture (Fig. 7). In particolar modo, non sono sempre chiarissimi i rapporti di continuità/discontinuità rispetto alle preesistenze, sebbene dai pochi dati stratigrafici a disposizione sembrerebbe che le chiese sarebbero sorte su strutture già parzialmente de-funzionalizzate; risulta però altrettanto plausibile ipotizzare che gli insediamenti su cui andarono ad insistere avessero avuto tratti di continuità, perlomeno parziale, altrimenti mal si spiegherebbe l'edificazione di complessi di tale portata in ambiti non più antropizzati. Ne consegue, dunque, che per i pochi dati a nostra disposizione per l'epoca tardo antica, la rete della cura animarum sembrò ad andare a incardinarsi, in ambito rurale, su una rete di poli demici ‘selezionati’, posti nei pressi delle più importanti vie di comunicazione, non lontani dalle città più importanti.Footnote 46 Tale aspetto, dunque, sembrerebbe denotare un'organizzazione della rete ecclesiastica che, nelle campagne, ancora doveva strutturarsi pienamente (ma era comunque attiva e vitale), secondo una conformazione che, evidentemente, in tale forchetta cronologica non può definirsi ‘parrocchiale’ ma, piuttosto, di “pre-parrocchia”.Footnote 47

Fig. 7. San Pietro in Campo (A) e San Piero a Grado (B) nelle loro fasi di fine IV-inizi V secolo d.C. (elaborazione dell'a.).
IL RADICAMENTO DELLA GEOGRAFIA ECCLESIASTICA IN ETÀ LONGOBARDA
La schedatura, allo stato attuale della ricerca, ha rivelato fin da subito come l'alto medioevo e, segnatamente, l'VIII secolo d.C., costituisca il momento di configurazione definitiva di una rete di edifici ecclesiastici ben strutturata e gerarchizzata, che sembrò affermarsi come una vera e propria esplosione. Per valutare tali fenomeni, in prima istanza, risulta fondamentale considerare il mero dato quantitativo che, in qualche modo, da solo enuncia con evidenza il picco di nuove fondazioni attestate a partire dal secolo VIII; in seconda battuta, però, anche questo valore deve essere valutato criticamente, in quanto la maggior parte delle menzioni presenti nelle carte proviene dagli archivi di Lucca che, come noto, costituiscono uno dei più ricchi patrimoni documentari dell'alto medioevo europeo.Footnote 48
Quest'ultimo aspetto non è da ritenere secondario in quanto, se da un lato sicuramente tale bacino di informazioni costituisce un'eredità preziosissima nell'economia della ricerca, dall'altro rischia di portare a sopravvalutare determinate aree geografiche e cronologie rispetto ad altri ambiti, anche circonvicini, che al confronto appaiono inevitabilmente sperequati.
Indubbiamente, Lucca ed il suo territorio diocesano rappresentarono comunque uno dei traini dell'affermazione del sistema pievano, in quanto le attestazioni rivelano innegabilmente un fervore di fondazioni di edifici ecclesiastici senza paragoni, da riconnettere molto probabilmente anche alla grande importanza che il centro godette nei secoli longobardi. Nonostante ciò, però, dalle informazioni desumibili incrociando fonti scritte e dato archeologico, il VII secolo d.C. sembra ancora essere un momento in cui la formazione di una solida rete ecclesiastica in ambito rurale stentasse ancora ad affermarsi definitivamente.Footnote 49 Non sembrerebbe, infatti, essere nemmeno casuale che le prime attestazioni del termine plebs siano tracciabili in documenti di fine VII-inizi VIII secolo d.C. (Violante, Reference Violante1982: 1015–16) (plebes che, nel fondamentale contributo di L. Nanni sulla “parrocchia” lucchese, 1948: 48–49, 59–65, erano ritenute avere funzione battesimale sin dall'alto medioevo), riferendosi, spesso indistintamente, sia al piviere, cioè il territorio di riferimento a cui faceva capo la chiesa battesimale, sia all'edificio di culto stesso. Questo ‘buco’ potrebbe essere spiegato come un momento in cui le aristocrazie ‘laiche’ stavano affrontando, perlomeno nel territorio di nostro interesse, un momento di assestamento, ancora legato alla necessità ineluttabile di un iniziale radicamento in ambito urbano, con la formazione della curtis regia a Lucca (attestata comunque anch'essa dagli inizi dell'VIII secolo d.C.). D'altro canto, secondo un processo per certi versi analogo, probabilmente anche le gerarchie ecclesiastiche in tali fasi stavano ancora vivendo un processo di graduale strutturazione e definizione, che si sarebbe compiuto pienamente solo dalla fine dell'VIII-inizi del IX secolo d.C., con una “nuova centralità della cattedra vescovile” (Stoffella Reference Stoffella2007a: 10). Se si guarda inoltre alle forme insediative in ambito rurale, il VII secolo d.C. sembrerebbe essere proprio il torno cronologico in cui si viene ad assistere ad una progressiva riorganizzazione delle forme demiche (Valenti, Reference Valenti2004: 94), sulla lunga onda della destrutturazione dei paesaggi ‘romani’, mentre sarà solo dall'VIII secolo d.C. che i nuovi possesores diverranno, de facto, una classe ormai stabilizzata.Footnote 50 Non appare infatti casuale che, anche nei contesti rurali, sia le fonti scritte che i dati archeologici denuncino in maniera incontrovertibile, da un lato, l'esplosione di nuove fondazioni ecclesiastiche e, dall'altro, il potenziamento di alcune di quelle già esistenti,Footnote 51 proprio a partire dall'VIII secolo d.C. (Fig. 8). È il caso ancora una volta di San Genesio, la cui chiesa agli inizi dell'VIII venne interessata da una spettacolare monumentalizzazione ed ingrandimento (Cantini, Salvestrini, Reference Cantini and Salvestrini2010), divenendo addirittura il luogo in cui verrà discussa la nota disputa tra i vescovi di Siena ed Arezzo (Felici, Reference Felici2009) (al 715 d.C. si attesta la sua prima citazione come ad ecclesiae Sancti Genesii, in uico qui dicitur Uualari) (CDL/I, n.20). Analogamente, sempre nell'VIII secolo d.C., la già citata Sant'Ippolito di Anniano viene notevolmente ampliata e ristrutturata, dotandosi pure di un fons baptismalis per assolvere alla funzione di cura animarum (attestata come ecclesia baptismalis Sancti Ipoliti sita loco Aniano nel 787 d.C.),Footnote 52 così come importanti interventi di ristrutturazione vengono documentati a San Piero in Campo (Redi, Reference Redi, Ceccarelli Lemut and Sodi2003). Chiari esempi, inoltre, sono ben ravvisabili nell'analisi del tessuto urbanistico di Lucca, ove nel corso dell'VIII secolo si assiste ad una vera e propria esplosione di novelle fondazioni ecclesiastiche, sia intra moenia che extra moenia: in tal senso, la netta riconfigurazione topografica che si venne a determinare nell'immediato suburbium meridionale lucchese (presso Porta San Pietro) è esemplificativa della propulsione edificatoria di edifici ecclesiastici che occorse in queste cronologie. In questo bacino topografico, una diretta emanazione delle élites longobarde è costituita dal complesso di S. Silvestro in Placule (messo in opera foris porta cuius civitatis qui dicitur S. Petri):Footnote 53 esso è attestato, con atto di fondazione, nel 720 d.C. e venne dotato di un sinedoco vel balneo cum fundamentis vel ortas (CDL, I, n.24), testimoniando inoltre una significativa presenza di entità assistenziali. Oltre al S. Silvestro in Placule qui vennero erette anche la chiesa di S. Pietro Maggiore, menzionata nel 740 d.C. (CDL, I, n.73), quella di S. Piero Sumualdi, nel 763 d.C. (CDL, I, n.70), S. Vitale in Placule, fondata da qd. Sichipertus nel 790 d.C. (MD/V, n.231) e, ancora, i SS. Giacomo e Filippo in Placule, eretta a fundamentis, prope muro istius civitatis (MD/V, n.231). Appare evidente, dunque, come avvenne anche per il burgus di S. Frediano nella parte settentrionale del suburbium lucchese, che anche in questo caso le aree suburbane – in particolar modo quelle arroccate nei pressi delle porte – fossero divenute tra i più significativi poli attrattivi sia dell'edilizia ecclesiastica che di nuclei residenziali ed assistenziali, configurandosi come i principali vettori dei nuovi equilibri topografici di cui la città post classica si fece portatrice. In tale ottica, le porte divengono elementi ‘attrattori’ e, dall'altro, assumono la denominazione del santuario (o dei santuari) più importanti attestati nelle loro immediate vicinanze.

Fig. 8. Dati quantitativi inerenti le fondazioni di edifici di culto cristiano in ambito rurale (elaborazione dell'a.).
Le motivazioni potrebbero legarsi da un lato al fatto che negli spazi intra muros, ormai, la trama degli edifici di culto cristiano fosse ormai talmente radicata che non si necessitasse più di nuovi e grandi cantieri, privilegiando piuttosto restauri e rifacimenti, anche importanti e, dall'altro, a gestioni dei patrimoni che ormai vedevano negli ambiti rurali il nuovo volano delle politiche gestionali, un fenomeno che si radicherà ulteriormente in età carolingia, in stretta relazione con l'affermazione del sistema curtense e dell'apparato di riscossione delle decime (Ronzani Reference Ronzani2014).
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: PER UNA PARZIALE RIDISCUSSIONE DI VECCHI MODELLI
I dati analizzati e discussi in questo contributo si inseriscono evidentemente all'interno di problematiche molteplici e in parte già avviate e consolidate nel dibattito europeo. È evidente che la ricerca qui presentata non possa essere esaustiva né, tantomeno, conclusiva, dal momento che numerosi sarebbero gli aspetti da approfondire ulteriormente, da demandare, però, per motivi di spazio, a futuri studi. Tra di essi spicca l'analisi della diffusione delle istituzioni monastiche, solo in parte tratteggiata, che fu un fenomeno di grande impatto proprio a partire dall'età longobarda, sia in città che nelle campagne, così come un tentativo di analisi dello sviluppo delle aree funerarie in relazione alla nuova geografia della topografia chiesastica. Quest'ultimo aspetto è, però, in parte compromesso da una scarsa conoscenza su base archeologica delle necropoli, le cui indagini sono spesso risultate limitate solo a comparti ristretti che, di fatto, spesso impediscono una comprensione ‘globale’ delle trasformazioni delle usanze funerarie. A livello più generale, indubbiamente uno degli aspetti più significativi è determinato dalla questione inerente l'importante momento di passaggio dalla civitas classica a quella medievale, un argomento che ha fatto stendere fiumi d'inchiostro a storici ed archeologi e di cui, per questioni di spazio, risulterebbe pressoché impossibile tracciare un quadro bibliografico completo. Come ampiamente noto, il principale oggetto del contendere è sempre stato quello della continuità, discontinuità o trasformazione della città nei delicati secoli tardo antichi ed altomedievaliFootnote 54 e, anche nel nostro caso, non possiamo esimerci dal confrontarci con tale discussione.
Nel corso del III secolo d.C., come abbiamo visto, si assiste in numerose delle città da noi analizzate a fenomeni abbastanza generalizzati di riconversione delle strutture afferenti all'epoca classica che, ad una facile lettura, potrebbero essere ascritti alla ben nota ‘crisi del III secolo’;Footnote 55 ciononostante, ad un'analisi più approfondita, tali evidenze sembrerebbero piuttosto da attribuire ad un momento di riconfigurazioni urbanistiche del tutto fisiologiche nell'ambito di importanti centri urbani che, se da un lato furono forse specchio di momentanei tratti di recessione, non sfociarono mai in una vera e propria ‘crisi’,Footnote 56 come ben testimonia il caso di Lucca. Sembrerebbe dunque venir meno il paradigma destrutturante proposto nella relativamente recente e monumentale opera di W. Liebeschuetz (Reference Liebeschuetz2001: 401), per cui “in the West the classical city in its full glory did not survive beyond the third century”, secondo un approccio che sembra molto vicino al “massimo oggetto desueto” di carandiniana memoria (Carandini, Reference Carandini1993). Tali letture pienamente ‘catastrofiste’ (tra le quali di recente si è addirittura parlato di “fall and decline of the Urban Roman Mind”) (Fischer, Lejdegård, Victor, Reference Fischer, Lejdegård, Victor, Sinclair, Nordquist, Herschend and Isendahl2010), pur tenendo conto, in alcuni casi anche ampiamente, dell'importanza rivestita dalla formazione della topografia cristianaFootnote 57 proprio a partire dal secolo successivo a quel III visto come sorta di punto di non ritorno, de facto vedono questo stesso fenomeno come un qualcosa di separato rispetto alle trasformazioni della città tardo antica, un evento disgiunto dalla globalità complessiva del corso della storia politica, sociale, financo monumentale dei centri urbani tardo romani.Footnote 58 Se guardiamo, però, all'impatto che la formazione di una gerarchia ecclesiastica ebbe, in ambito urbano, anche in termini materiali e topografici, con le importanti ecclesiae episcopales di Luni, Lucca e Firenze, solo per citare i casi più noti, risulta difficile pensare a città in irreversibile recessione, se non addirittura in piena crisi: tali imprese edilizie (congiuntamente agli altri importanti poli religiosi intra muros, nonché alle chiese funerarie dei suburbia, come la Santa Felicita fiorentina o il San Frediano luchese) configurano, piuttosto, precise volontà di attecchimento in centri che sono ancora a tutti gli effetti “città ricchissime di attività, ma con una scarsa monumentalità […], ma ciononostante possono essere considerate a pieno titolo centri urbani” (Wickham, Reference Wickham2009: 710). La strutturazione e progressiva cristallizzazione della topografia cristiana, dunque, comporta la ridefinizione di quegli equilibri di potere e di ‘geografia urbana’ che erano stati propri della civitas classica, che evidentemente muta, anche profondamente, ma rimane comunque attiva, popolata e, soprattutto, catalizza importanti investimenti in termini edilizi. Nelle città qui analizzate, gli edifici di culto cristiano, a partire dalla fine del IV secolo d.C. e, soprattutto nel corso del V e del VI, determinano, dunque, una scomposizione della visione centripeta della città romana, che ora, in qualche modo, tramite la forte presenza della gerarchia ecclesiastica, si articola in più poli aggregativi, che sono al contempo espressione di potere e di nuovi accentramenti insediativi, come di recente evidenziato anche da N. Christie (Reference Christie2006: 206), secondo il quale “the Christianization of space created towns with new poles of attraction, drawing attention progressively away from the old urban cores” e come del resto già rilevato, tra gli altri, pure da P. Testini (Reference Testini1986) e da N. Gauthier (Reference Gauthier, Brogiolo and Ward-Perkins1999). Come già evidenziato, sarebbe comunque metodologicamente scorretto separare le evidenze inerenti gli edifici di culto cristiano tardo antichi ed il loro impatto sulla topografia urbana ‘laica’:Footnote 59 infatti, in particolar modo, i complessi episcopali ebbero un impatto topografico ‘irreversibile’ sugli assetti classici delle città. In quasi tutti i casi analizzati le ecclesiae episcopales furono edificate in zone periferiche rispetto alla centralità degli spazi urbani tipicamente classici, seppur sempre in ambito propriamente urbano (si veda di nuovo la Fig. 3). Se si osservano le trasformazioni che intercorsero nelle città tardo antiche sopra descritte, è evidente che tra III e V secolo d.C. si determinarono in nuce riconfigurazioni incontrovertibili nelle gestione degli spazi urbani che troveranno continuità nei secoli successivi. È ancora Lucca ad essere uno degli esempi maggiormente rappresentativi in tal senso: come visto, entro la fine del III secolo d.C. una fabbrica di spathae, espressione diretta del potere imperiale, venne impiantata all'interno dello spazio urbano (Ciampoltrini, Notini, Reference Ciampoltrini and Notini1990: 590), e solo un secolo più tardi il complesso episcopale (dunque con ecclesia episcopalis, battistero ed episcopium)Footnote 60 si installò nella parte sud-est della città, occupandone un vasto spazio. Osservando anche i suburbia, è possibile testimoniare cambiamenti fondamentali nelle percezioni spaziali che il cristianesimo diede anche alle zone extraurbane: a Firenze, le quattro più importanti chiese funerarie/martiriali vennero costruite sui quattro differenti punti cardinali, in corrispondenza dei principali setti viari e nei pressi immediati delle porte cittadine; ancora a Lucca la chiesa di San Frediano andò ad insistere nel suburbio settentrionale, sviluppando un reale ed alternativo polo di urbanesimo, il cosiddetto Burgus Frigdiani (Ciampoltrini, Notini, Reference Ciampoltrini and Notini1990: 590). Il suddetto fenomeno di attrazione determinato dalle porte urbane è qualcosa che caratterizza trasversalmente lo sviluppo di molte città nell'Italia tardo antica ed alto medievale, e, non solo, gli edifici martiriali iniziarono ad essere percepiti come baluardi protettivi delle città stesse, come ci dice anche Avito di Vienne: “quorum inexpugnabiliter, recte ut confidimus, […] plus haec basilicis quam propugnaculis urbs munitur: cingitur undique […] tutamine sacrarum aedium dives accessus, et ad portarum quamvis patentium […] limina tutiora nisi sanctis ianitoribus non venitur”.Footnote 61
Più complessa è forse la discussione del dato inerente gli ambiti rurali: l'approccio allo sviluppo storico-topografico delle campagne toscane, infatti, deve inevitabilmente confrontarsi con un modello ‘forte’ e da anni ormai consolidato, ossia il cosiddetto “Modello toscano”. Quest'ultimo, promosso nell'ambito della scuola senese di Riccardo Francovich, vede, in estrema sintesi, un paradigma diacronico articolato secondo i seguenti punti: “a) Decadenza del sistema delle ville e dell'organizzazione del popolamento rurale tra V e VI secolo con un'accentuazione progressiva della crisi b) Formazione del villaggio altomedievale intorno agli inizi del VII secolo, con il passaggio all'insediamento accentrato come forma di popolamento predominante c) Ruolo “debole” delle aristocrazie almeno sino alla metà del VII secolo che mostrano di assumere iniziative di maggior portata nell'organizzazione della campagna soprattutto dall'VIII secolo d) Trasformazione di molti villaggi in aziende che si realizza attraverso l'adattamento della curtis alle strutture del villaggio stesso nel corso del IX secolo e) Evoluzione dei villaggi in castelli al cui interno convivono nel X secolo sia la connotazione aziendale sia l'aspetto di dominio sul territorio” (Valenti, Reference Valenti2004: 193). All'interno di questi cinque punti ne va inevitabilmente incardinato un sesto, ossia quello inerente la topografia cristiana, che, sulla scia di Cinzio Violante (vedi supra), vede nelle campagne toscane di epoca tardoantica ed altomedievale (fino almeno all'VIII secolo d.C.) una rete ecclesiastica scarsamente strutturata, sia dal punto di vista della cura d'anime che del controllo del territorio. Se si associa questo tipo di esegesi ai dati eminentemente quantitativi proposti (Figg. 8 e 9) il modello stigmatizzato da Violante sembrerebbe, ad un primo sguardo, avere una propria coerenza ed organicità, ma il dato quantitativo, da solo, non sembra essere esaustivo di una questione che, analizzando anche gli aspetti ‘qualitativi’, appare più complessa e di soluzione meno immediata. Se è pur vero che i contesti di edifici di culto cristiano nei secoli pienamente tardo antichi risultino, nelle campagne toscane, numericamente piuttosto ridotti, rivelano comunque, nelle proprie tipologie, indizi chiari ed inequivocabili di investimenti importanti. Se si guarda, ad esempio, ad un contesto come San Piero a Grado, ci si trova di fronte ad un edificio ecclesiastico che, già a fine IV-inizi V secolo d.C., ha proporzioni e dimensioni del tutto affini a quelle delle grandi ecclesiae episcopales urbane, e allo stesso modo, grande importanza riveste, nella medesima cronologia, anche la chiesa di S. Pietro in Campo, dotata di un ampio battistero e, dunque, destinata alla cura animarum delle zone rurali. Evidentemente, dal punto di vista numerico si ribadisce come i dati siano esigui, ma contesti come quelli appena menzionati sembrerebbero tradire un'organizzazione e strutturazione, seppur forse ancora parziali, della rete ecclesiastica che, in nuce, iniziò ad essere presente già in epoca tardo antica, forse tracciabile prettamente lungo le principali direttive di comunicazione, sia viarie che fluviali (come enucleano le georeferenziazioni dei siti in rapporto al paesaggio antropizzato), imponendosi come progressivo elemento caratterizzante dei rinnovamenti insediativi delle campagne tardo antiche (Brogiolo, Chavarría Arnau, Reference Brogiolo, Campana, Felici, Francovich and Gabbrielli2008: 23).

Fig. 9. Dati quantitativi inerenti le fondazioni di edifici di culto cristiano in ambito urbano e rurale a confronto (elaborazione dell'a.).
Come già evidenziato, il progredire verso i secoli altomedievali rappresentò un deciso aumento quantitativo degli edifici ecclesiastici, soprattutto nell'VIII e nel IX secolo d.C. (vedi supra): tale aspetto, in un'ottica quantitativo-qualitativa, è stato recentemente preso in esame in un bello studio di R. Farinelli (Reference Farinelli, Sánchez-Pardo and Shapland2015a), concentrato sull'areale lucchese. Lo studioso ha rilevato innanzitutto come il picco massimo, in età longobarda, ricada nel venticinquennio 750–775 d.C. (Farinelli, Reference Farinelli, Sánchez-Pardo and Shapland2015a: 163): si tratta di un dato di notevolissimo interesse, dal momento che anche nelle fondazioni intra moenia note per Lucca la tendenza quantitativa risulta analoga.Footnote 62 Questo fenomeno potrebbe spiegarsi, da un lato, con uno stretto legame tra fondazioni di chiese e proprietà fondiarie, come evidenzia ancora Farinelli (Reference Farinelli, Sánchez-Pardo and Shapland2015a: 163–65), ma anche come un modo per estendere “l'evoluzione dell'attività di controllo esercitata dall'aristocrazia diocesana nei confronti delle élites periferiche e locali” (Stoffella Reference Stoffella2007b: 29), senza che un fenomeno escluda l'altro, anzi. L'espandersi del numero di chiese nelle campagne dell'Italia Longobarda, inoltre, avrebbe contribuito anche alla maggiore e migliore definizione dei territori di pertinenza di ciascun piviere, ove “nel secolo VIII il territorio della chiesa battesimale tendesse a consolidarsi e le chiese minori in esso presenti […] fossero propense a disciplinarsi nella comune dipendenza dalla chiesa battesimale stessa” (Azzara, Reference Azzara and Brogiolo2001: 11).
In guisa di conclusione, si ritiene opportuno stigmatizzare per punti gli aspetti principali che determinarono la declinazione materiale del cristianesimo dall'età tardo antica sino al volgere dell'epoca longobarda:
Per le città:
– Dalla fine del IV sec. agli inizi del VI la topografia cristiana è pienamente definita, conquistando sia gli spazi urbani che quelli suburbani
– Le ecclesiae episcopales note si impostano in zone ‘periferiche’ (secondo un modello ‘trasversale’) e insistono in aree occupate quasi sempre da preesistenze di carattere privato (domus)
– A partire dall'età tardo antica e per tutto l'alto medioevo, gli edifici cristiani divengono “fattori poleogenetici” (con L. Pani Ermini, Reference Pani Ermini1998), imponendosi come attrattori dei nuovi equilibri insediativi urbani e suburbani e catalizzando anche nuclei funerari organici (soprattutto dal VI sec.) e officine artigianali
– A partire dall'età longobarda si documenta una vera e propria esplosione delle nuove fondazioni, soprattutto private, segno di una volontà di autorappresentazione e di affermazione delle élites laiche che, però, si muove di concerto con un mutuale interscambio con le autorità ecclesiastiche, in primis i presuli lucchesi.
– In età longobarda e carolingia si sviluppano anche numerosi monasteri urbani e suburbani, spesso legati anche ad hospitalia e xenodochia.
Per le campagne:
– In età tardo-antica si sviluppano importanti poli cristiani ‘selezionati’, attestati su bacini topografici strategici, ovverosia in prossimità delle più importanti vie di comunicazione (fiumi, strade, porti, etc.)
– Di difficile soluzione è il rapporto tra chiese rurali e preesistenti insediamenti di età classica, ma appare estremamente plausibile ritenere che le fondazioni fossero vagliate dall’imprimatur episcopale, sebbene vi fossero delle eccezioni, come testimoniato dalle fonti che rivelano la preoccupazione delle autorità ecclesiastiche per le fondazioni private: si viene a sviluppare un ‘vantaggio reciproco’ tra élites laiche e chiesa?
– Dall'VIII secolo, soprattutto nella seconda metà, si documenta un grande exploit delle fondazioni ecclesiastiche rurali, spesso legate a donazioni di famiglie laiche, desiderose sia di effettuare donativi pro anima, ma anche di estendere il proprio controllo alle risorse terriere. Dall'età carolingia, la persistenza di questo fenomeno si legò precipuamente alla necessità di effettuare la riscossione delle decimae.
Ovviamente, rimane un grosso problema esegetico legato alla già citata carenza di un vasto bacino di informazioni archeologiche, che portava R. Francovich (Reference Francovich and Valenti2004: IX-XXII, XVII) ad affermare che “in Toscana le conoscenze sulle chiese rurali tardo-antiche e alto-medievali sono scarse, soprattutto nei loro rapporti con i quadri insediativi complessivi”, per cui la percezione di determinati fenomeni dovrebbe essere, a parere di chi scrive, affrontata, allo stato attuale delle nostre conoscenze, con maggior prudenza critica ed in maniera meno tranchant, in quanto, come evidenziato, i seppur pochi dati a disposizione suggeriscono un sottobosco di informazioni che potrebbe indirizzare verso parziali riletture di modelli eccessivamente pessimistici. Per concludere, dunque, in un'ottica globale e di longue durée, sembrerebbe forse opportuno, come recentemente sollecitato da H. Dey (Reference Dey2014: 250) nel suo bel libro The Afterlife of the Roman City, sorpassare quei rigidi paradigmi legati alle idee di ‘catastrofismo’ o ‘continuità’, che rischiano di distogliere dalla multi-sfaccettata complessità di determinati fenomeni, distraendo “from the more complicated, messy and fascinating situation on the ground”.