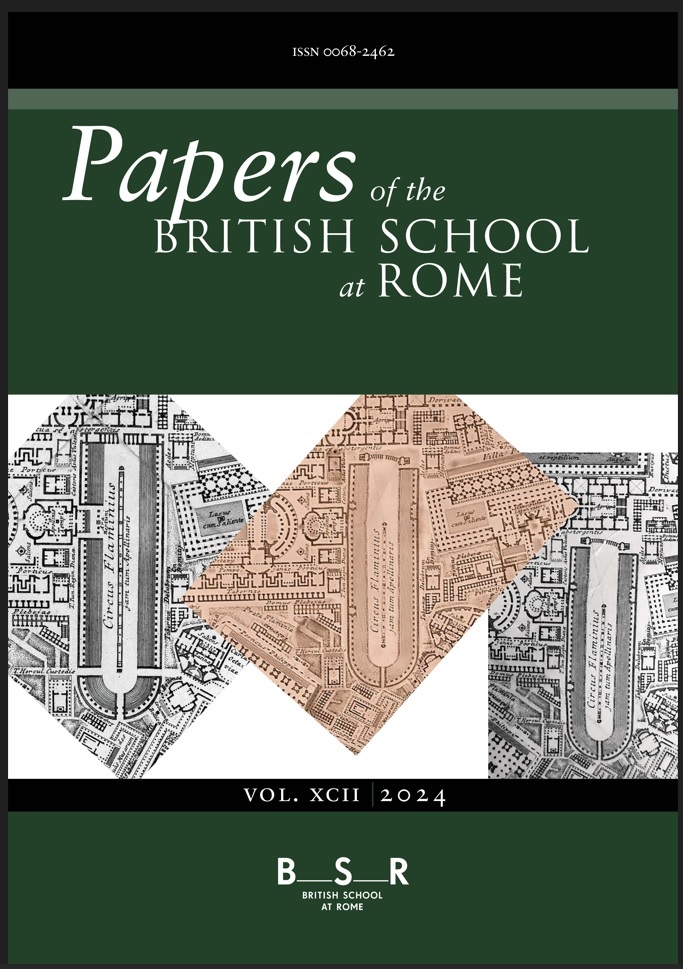Salvati dall'oblio da Thomas Ashby, che li acquistò nel 1902, nella biblioteca della British School at Rome sono conservati diversi documenti manoscritti di Diego de Revillas,Footnote 1 matematico e antiquario, naturalista e topografo;Footnote 2 il suo nome è legato alla nascita della cartografia moderna, e – negli studi di topografia romana – anche all'ordinamento dei frammenti della pianta marmorea severiana nello scalone di Palazzo Nuovo, in Campidoglio, nel 1742.
Come è noto, furono in quell'occasione per la prima volta esposti al pubblico i frammenti della Forma Urbis, inseriti in venti riquadri che grosso modo seguivano la sequenza e la disposizione delle tavole che illustravano l'edizione della pianta marmorea di Giovan Pietro Bellori (1673); si aggiunsero poi sei ulteriori pannelli con frammenti che non erano stati presi in considerazione nella pubblicazione dei marmi farnesiani. Questa sistemazione (1742–1903)Footnote 3 era destinata ad avere grande influenza per la fortuna della Forma Urbis e per gli studi di architettura antica, ma la sua attuazione si presentò sin dal principio come un affare complicato.
Fu uno degli ultimi impegni di Alessandro Gregorio Capponi come presidente antiquario dei Musei CapitoliniFootnote 4 ed egli aveva colto subito le principali difficoltà, osservando che ‘sarà grande fatica per ridurre quella ad una cosa perfetta perché in prima il libro del Bellori fatto con l'aiuto del Bufalini architetto è molto mancante e difettoso di molte cose e non v’è scala, e poi, è più discorso Accademico, che fondato’.Footnote 5 Oltre i dubbi sull'affidabilità scientifica dell'edizione del Bellori, allora unico strumento di conoscenza dei frammenti, era dunque apparso subito fondamentale stabilire il rapporto di riduzione in scala della pianta marmorea severiana.
Soprattutto per questo motivo Capponi aveva consultato RevillasFootnote 6 ed è possibile che la sfida ‘metrologica’ interessasse il matematico più di quella topografica ed antiquaria.Footnote 7 L'abate di S. Alessio coinvolse il suo protetto Giovanni Battista NolliFootnote 8 e lui, a sua volta, un giovane aiutante (la cui identità è discussa, ma è stato autorevolmente richiamato il nome di Giovanni Battista Piranesi).Footnote 9
In un importante articolo Olivier Michel ha minutamente analizzato le note spesa di Nolli, preparate per la fatturazione e conservate nell'Archivio Segreto Vaticano.Footnote 10 Il documento restituisce in primo luogo i tempi – brevissimi, poco più di due mesi di lavoro effettivo –, i riscontri sul terreno e sulla cartografia storica. Le diverse voci della fattura non sono datate, né sono in sequenza cronologica, ma conosciamo i tempi: la consegna ufficiale dei frammenti avvenne al principio di maggio e la presentazione al Pontefice del lavoro compiuto nel novembre.Footnote 11 In realtà si cominciò ad organizzare il lavoro al principio di aprile e i riquadri furono montati sullo scalone verso la fine di agosto.Footnote 12
A questo importante documento possiamo ora affiancare i fogli dell'Archivio Revillas conservati nella biblioteca della British School: questi testimoniano un metodo di ricerca che suscita ammirazione ma dimostrano chiaramente che il rapporto corretto di riduzione in scala – contrariamente a quanto abbiamo credutoFootnote 13 – non fu trovato.
Sono tre i documenti che riguardano la Forma Urbis,Footnote 14 in una busta contenente materiale decisamente eterogeneo che giustifica la nota ‘schede informi del padre Revillas’Footnote 15 sulla cartella che tiene insieme le pagine. I fogli, che indicherò a, b e b1 (quest'ultimo è un piccolo appunto inserito tra le pagine del foglio b) (Figs 1–3) presentano una grafia stretta e minuta, volta verso destra. Gli elementi comuni sono numerosi. Potrebbe essere la stessa mano nei fogli a e b ma è difficile averne certezza: la scrittura, corsiva e più disordinata nel foglio a, è invece più regolare e in buona copia nel foglio b. In entrambi i casi sono forti le analogie con altri documenti contenuti nell'archivio ma è difficile stabilire se si tratta della mano di Revillas o di altro suo collaboratore.Footnote 16

Fig. 1. British School at Rome Library, Archivio Revillas, busta 81: foglio a.

Fig. 2. British School at Rome Library, Archivio Revillas, busta 81: foglio b.

Fig. 3. British School at Rome Library, Archivio Revillas, busta 81: foglio b1.
L'analisi dei testi rende evidente, come si vedrà, che si riferiscono a due diversi momenti del lavoro relativo alla sistemazione della pianta marmorea. Il foglio b rappresenta la fase finale dell'opera e si confronta, con qualche significativa differenza, con l'elenco dei luoghi oggetto delle verifiche stilato nella fattura del Nolli.
Attraverso la fattura di Nolli all'Archivio Vaticano conosciamo i monumenti oggetto dei rilievi e delle misurazioni di controllo: il Colosseo, la tholos del Foro Boario (S. Maria del Sole); il tempio di Portuno (S. Maria Egiziana); il Teatro di Pompeo; il Mausoleo d'Augusto; il tempio di Saturno (il ‘colonato antico sotto il Campidoglio’); i resti presso S. Maria in via Lata (le ‘Septe’), il Teatro di Marcello. Quello che non si conosceva, ed è ora rivelato dai manoscritti della British School, è su quali frammenti della pianta marmorea erano stati stabiliti i confronti.
Studiando l'elenco dell'Archivio Vaticano, Michel (Reference Michel1983: 1008) si domandava come fossero potuti riuscire nell'impresa di trovare la scala di riduzione quando gli unici confronti possibili erano il Teatro di Marcello e il Teatro di Pompeo: ‘Nolli prend huit points de référence, six sont faux!’ Le carte dell'archivio Revillas restituiscono metodo, modalità del lavoro e soprattutto le fonti delle indagini sul terreno, a proposito delle quali lo studioso francese avrebbe forse aggiunto un altro punto esclamativo, perché non sono sbagliati sei confronti su otto: i riscontri conclusivi sono sbagliati tutti.
Foglio a
Nella sequenza cronologica viene prima il foglio a (Fig. 1), in latino. Corrisponde alla fase dell'organizzazione del lavoro e della ricerca, probabilmente già nel maggio 1742, e si può mettere in relazione con la voce della fattura del Nolli: ‘Per essere andato col R.mo P. Ab.e Revillas nella Libraria Vaticana à rincontrare le tavole del Bellori’. Si tratta chiaramente di una schedatura, tavola per tavola, che Nolli e Revillas misero a punto a proposito delle più promettenti identificazioni del Bellori, a volte citato anche verbatim (i passi relativi in corpo minore sotto le singole voci):
Tab. II. Ichnographiam Septizonii v. apud Panvinium de ludis circens. ad circi Maximi ichnographiam (?)
Bellori 1673: 11: ‘unde ultimum huius tabulae aedificium, triplici murorum praecinctione, Septizionium esse severianum arbitratur; cum Onophrius Panvinius non dissimile Septizonij vestigium ostendat libro de Ludis Circensibus in Circi Maximi Ichnographia.’
Tab. V Lavacrum, et templo in platea Solis
Bellori 1673: 24: ‘Rotundi ambitus vestigium porticu, columnisque circumductum aedis esse, quae adhuc stat inter ripam Tiberis, & Ecclesiam B. Virgis cognomento Cosmedin, titulo Sancti Stephani denominata, existimat Andreas Bufalinus…. Iuxta hanc aedem alterum in nostra tabula vestigium extat, quod idem Bufalinus esse autumat proximi templi Fortunae Virilis, nunc S. Mariae Aegyptiacae nuncupati.’
Tab. VII Aliud Septizonium comparas cum Panvinii ichnographia
Bellori 1673: 31:‘Alterum superius vestigium balneo imminens substructione triplici murorum…Septizonij alterius vestigium esse videntur a Severiano diversum.’
Tab. IX templi Concordiae vestigia comparas cum vestigis in foro Boario
Bellori 1673: 39: ‘Agnoscit Bufalinus in hoc vestigio Templo Concordiae in clivo Capitolino imminens Foro…’
Tab. X Septa. Exploramus vestigia sub aede Pamphiliana ex Bufalino latitudo porticus prima, viae Latae, conterminae, est palm. 26
Bellori 1673: 43: ‘Andreas Bufalinus huius aedificij reliquias agnoscit ad viam Latam in substructionibus aedium Aldobrandinarum; etenim super totidem pilis ex Tiburtino lapide aedes ipsae constructae sunt, …. Porticus sive ambitus primus viae Latae conterminus patet latitudine sua palmis 26 & coeteris amplior est quae maior latitudo etiam in nostro vestigio perspicua est; 44 : Agrippinorum septorum locum Nardinus designat inter Collegium Romanum et Capitolium, ubi et nos recognoscimus nostrum vestigium in Aldobrandinis aedibus. Opinamur tamen Saepta Iulia ab Agrippinis non fuisse diversa…’
Tab. XII Hecatonstilum – Vestigia huius (?) in Caelio amphiteatrum versus ex Bufallino
Theatrum Marcelli – V. Serlium lib. 3. De Architect.
Bellori 1673: 53: ‘Andreas Bufalinus ipsum vestigium refert ad insignes reliquias quae durant adhuc in Coelio, amphiteatrum versus…Videtur inde Hecatonstylum in Hostilium, seu Curiam Hostiliam corrupte commutatum’.
Tab. XV Theatrum Pompei ad Campum Florae. V. Buffallino
Bellori 1673: 65: ‘Theatri curva pars, spectatorumque cunei a Campo Florae tendebat se seque inclinabant a meridie viam Clauariorum versus ut & hodie in Ursinarum aedium stabulis fornicum descendentium circulariter ad orchestram, reliquiae spectantur: quas Bufalinus exhibet cum integra theatri descriptione in sua recentis urbi Ichnographia’
Tab. XVIII amphiteatrum
Tab XX Mausoleum Augusti
Foglio b
Più interessante, e molto più specifico, è il foglio b (Fig. 2). Le misurazioni verificano, come è chiaro dalle prime righe del foglio, l'attendibilità di una scala di 110 palmi per ‘la Pianta di Roma Antica scolpita in marmi che si mette nel Campidoglio. Fabriche ove corisponde la medesma’.
Di particolare importanza è la colonna di numeri romani sulla sinistra del foglio: indica il numero delle tavole del Bellori ed è dunque la chiave per comprendere quali erano i frammenti oggetto di confronti con i monumenti misurati sul terreno. I frammenti sono disegnati dunque alle tavole XVIII, V (tre diversi frammenti\monumenti), XV, IX, XII e XX e sono, come si vedrà, facilmente identificabili.
Nell'ordine:
XVIII. Al Colisseo in una parte p.mi 27,11 22,6 26,6 conrisponde in punto
in d.to in altra parte 25.0 22.10 conrisponde in punto
Nonostante la rassicurante annotazione ‘conrisponde in punto’, i frammenti rappresentati alla tavola XVIII (Fig. 4) dell'edizione dei marmi farnesiani sono relativi alla cavea del Teatro di Marcello e non al Colosseo:Footnote 17 la comparazione era stata in sostanza compiuta sui frammenti 31 npq (un quarto, andato perduto fu inserito in copia nel rispettivo pannello).

Fig. 4. Bellori 1763, tav. XVIII.
L'identificazione con il Colosseo è data per cosa certa dal Bellori e si deve a Piranesi la corretta interpretazione dei frammenti marmorei, che rettifica una delle più bizzarre ricostruzioni del Nolli, vale a dire un teatro di Marcello delineato in forma ovale – quasi ad anfiteatro – sui lati nord e sud-est.Footnote 18 Ci si domanda se non vi sia proprio l'abbaglio della tavola belloriana dietro questa ricostruzione: vale a dire se Nolli non abbia in qualche modo riconosciuto nel modulo e nella relazione metrica del monumento lo schema di quello che si riteneva essere un anfiteatro e non lo abbia poi, con un perfetto sillogismo errato, applicato al teatro di Marcello.
V. Chiesa della Mad.na del Sole, diametro interiore p.mi 37½ conrisponde in punto
In relazione alla tavola V dell'edizione di Bellori (Fig. 5), i rilevamenti sono compiuti nell'area del Foro Boario. L'immagine dalla Pianta Grande (n. 1089; Fig. 6) restituisce con immediatezza il ‘diametro interiore’ della chiesa, corrispondente alla cella della tholos.Footnote 19 Il confronto è però con il frammento 37 a, vale a dire il tempio B dell'area sacra di Largo Argentina (Fig. 7), che nella pianta marmorea è rappresentato secondo lo schema periptero della prima fase (tra fine II e inizi I secolo a.C.).

Fig. 5. Bellori Reference Bellori1673, tav. V.
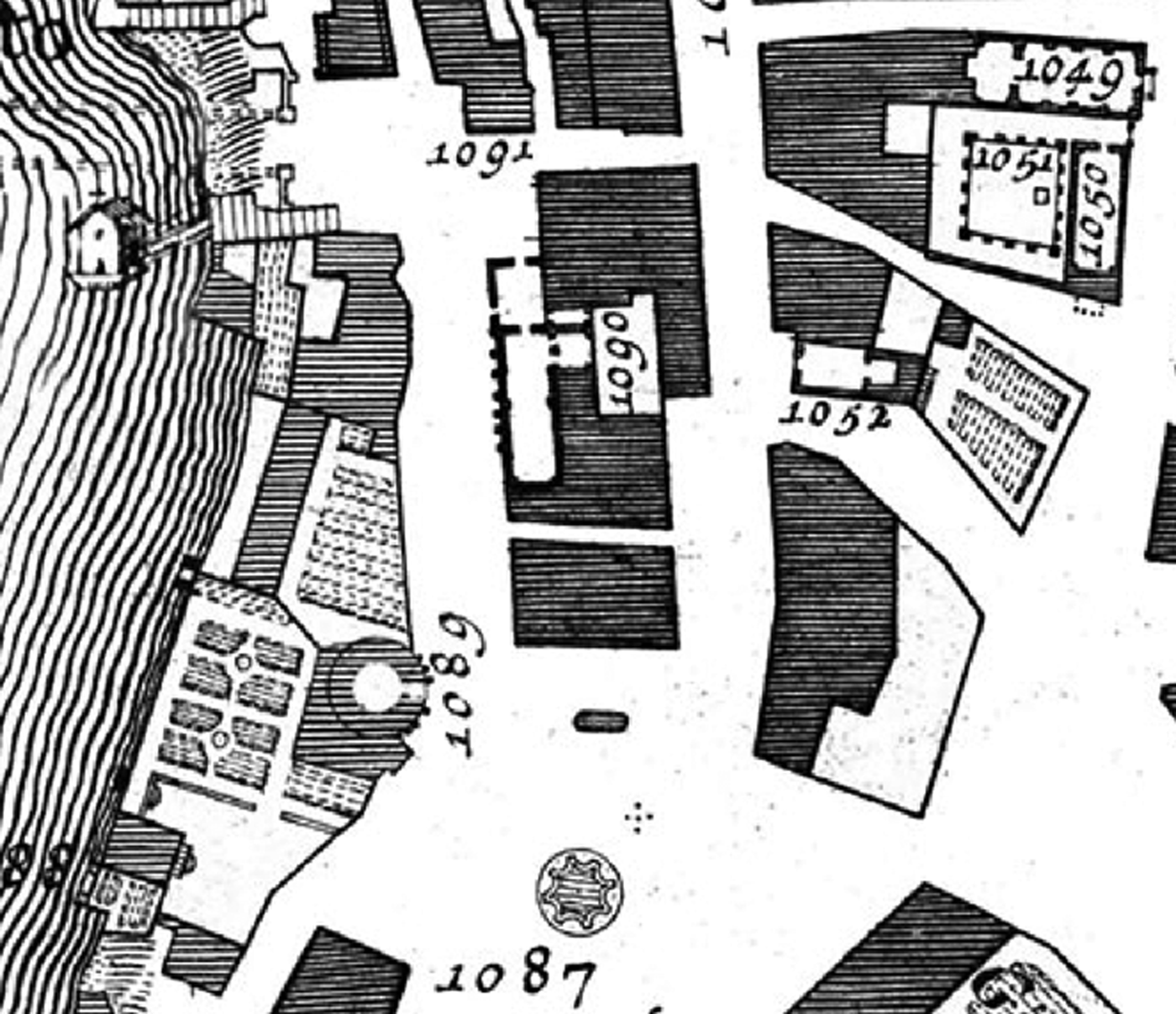
Fig. 6. G.B. Nolli, Nuova Pianta di Roma (1748). Particolare dei templi del Foro Boario.

Fig. 7. Pianta marmorea severiana, fr. 37 a (foto © Sovrintendenza Capitolina).
V. Chiesa di S.ta Maria Egizziaca, larghezza comprese le colonne
esteriori p.mi 45
Larghezza ne marmi p.mi 44 diferenza di p.mi 1
Lunghezza di detta chiesa di fuori p.mi 83
Lunghezza nei marmi p.mi 65 diferenza p.mi 18
In questo caso il confronto fu compiuto tra tempio di Portuno e tempio A di Largo Argentina,Footnote 20 seguendo ancora una volta l'interpretazione del Bellori (‘Iuxta hanc aedem alterum in nostra tabula vestigium extat, quod idem Bufalinus esse autumat proximi templi Fortunae Virilis, nunc S. Mariae Aegyptiacae nuncupati’).
L'accostamento tra un tempio pseudoperiptero tetrastilo e un periptero esastilo è singolare, essendo tanto più il primo (allora noto come Tempio della Fortuna Virile) uno dei più disegnati e studiati monumenti romani, da Palladio a Dosio a Desgodets e la cui facciata tetrastila era in ogni caso palese anche in assenza di ricostruzioni e studi architettonici.Footnote 21 Può forse avere avuto un ruolo nel confronto erroneo il numero delle colonne sui fianchi, uguali nel tempio del Foro Boario e nel frammento 37 a.Footnote 22
Colpisce soprattutto il fatto che non si tenne conto della diversa relazione tra i due templi – vicini ed allineati nella pianta marmorea – né della distanza: un mancato interesse per lo spazio vuoto, che pure è spazio in scala, che è una delle più gravi criticità della sistemazione di Palazzo Nuovo e che portò in diversi casi a tagliare le parti non incise dei frammenti, con conseguente perdita di importanti dati.
XV Teattro di Pompey larghezza de spartimenti p.mi 22
Larghezza de marmi p.mi 26 diferenza p.mi 4
L'unica identificazione corretta tra pianta marmorea e monumento reale rivela una mancata corrispondenza tra le misure. Nella pianta marmorea, la cavea del teatro in generale e l'articolazione delle spartizioni interne in particolare sono in ogni caso quasi per intero frutto di ricostruzione.Footnote 23 Le difficoltà di analisi rispetto al monumento reale, anche in possesso di basi documentarie più solide, erano state enucleate già da Colini ed uno studio più recente porta forse ad estrapolare uno dei due frammenti di cavea finora attribuito al monumento.Footnote 24 Impossibile dire in quale punto, sul terreno o nei marmi, siano stati misurati gli ‘spartimenti’.
L'analisi dei frammenti potrebbe avere avuto influenza sulla ricostruzione del teatro di Pompeo nella Pianta Grande (ma non, si direbbe, sul curioso orientamento della cavea: Ceen, Reference Ceen1990: 21; Triff, 2013: 133–145).
IX. Le sei colonne in Campo Vaccino
Schizzo misurato delle colonne tra la ‘strada che scende alla Consolazione’ e ‘parte sotto al Campidoglio’, in relazione al frammento rappresentato nella tavola IX del Bellori (Fig. 8). Il confronto con i prospetti moderni del tempio di SaturnoFootnote 25 dimostra una notevole precisione, nonostante le case e le strutture che occupavano il podio rendessero probabilmente difficile il rilevamento. Non è specificato, ma si tratta del primo confronto impossibile, essendo perduto il frammento 19 Footnote 26 che rappresentava l'angolo tra tempio di Saturno e tempio di Concordia (la localizzazione è contenuta nell'iscrizione [Conc]ordia).Footnote 27

Fig. 8. Bellori 1673, tav. IX.
XII. Palazzo Savelli teatro di Marcello non si è potuto venire in cognizione di niente per non esservi li marmi
Il riferimento è al frammento 31 lmrt con la scena del teatro di Marcello alla tavola XII del Bellori, spezzato e parzialmente disperso al momento della ricognizione dei pezzi.Footnote 28
V. Fabrica rotonda con tré scalinate nell'orto del sig.r Prp Altieri per andare à S.ta Croce in Gerusaleme non si è rincontrato per non esservi li marmi
Questo è l'unico confronto con un monumento non menzionato nel testo di Bellori. Si tratta del sepolcro monumentale sulla via Labicana e ai margini degli horti di Mecenate, noto come Casa Tonda, demolito nel corso dei lavori edilizi del quartiere Esquilino:Footnote 29 doveva essere ben presente a Nolli, che ne restituisce nella Pianta Grande la planimetria (Fig. 9).Footnote 30 La particolare articolazione delle strutture spiega il confronto con il frammento 35 m (il ‘Lavacrum’ nel foglio a; in realtà il tempio di Minerva Chalcidica del Campo Marzio),Footnote 31 elencato tra le architetture da confrontare alla tavola V del Bellori (Fig. 5).

Fig. 9. G.B. Nolli, Nuova Pianta di Roma (1748). Particolare dell'area di via Labicana.
XX. Mausoleo d'Augusto, si sono misurate le spartizioni e non si sono potute rincontrare per non esservi ne la pianta d.te spartizioni
Diametro esteriore di d.te p.mi 280
Il diametro interiore p.mi 180 da rincontrarsi nè marmi
Preso della mia pianta
Il riferimento è ai frammenti 13 c-e, g, l-n, rappresentati nella tavola XX (Fig. 10), in realtà pertinenti al Colosseo.

Fig. 10. Bellori 1673, tav. XX.
Il metodo e la scala di riduzione
Il foglio b è senza dubbio relativo alla messa in pulito di note e misurazioni fatte sul posto e costituisce la verifica di una tesi. Qui la selezione è già compiuta e l'ordine non segue le tavole belloriane ma i diversi gradi di conferma dei riscontri: calzanti in pieno le prime due voci, poi via via l'elenco delle differenze e delle verifiche impossibili, poiché i frammenti disegnati erano perduti (‘per non esservi li marmi’).
La menzione di una ‘scala di 110 palmi’ non è sufficiente per individuare il modello di concezione proporzionale, evidentemente studiato per essere applicabile sia alle dimensioni dei monumenti incisi sul marmo che alle misure reali. Si tratta chiaramente del palmo romano di architettura,Footnote 32 ma manca il primo termine della proporzione.Footnote 33 Fondamentale è piuttosto la scala grafica al principio del foglio, che costituisce la regula palmorum utilizzata per il confronto con i frammenti.
Il modulo della riduzione è ricostruibile con sicurezza per uno solo dei confronti compiuti, ma è sufficiente per constatare che – come si è detto – il rapporto corretto non fu trovato.
Si tratta della corrispondenza ‘in punto’ tra diametro della cella del tempio del Foro Boario (Chiesa della Madonna del Sole) e tempio B di Largo Argentina, come è rappresentato nella pianta marmorea.Footnote 34 Le misure sul terreno del monumento del Foro Boario prese da Nolli e dal suo assistente sono palmi 37.5 = m 8.3782. Il diametro interno del tempio B nel frammento della Forma è impossibile da valutare con precisione assoluta, per essere il cerchio non perfetto ed il marmo abraso, ma le dimensioni oscillano tra 5.5 e 5.6 cm. Nella scala grafica del foglio b cm 5.6 corrispondono esattamente al valore di palmi 37.5.Footnote 35 Ne deriva necessariamente una conversione in scala metrica di 1:149.6 circa siamo lontani dal range di tutte le ricostruzioni future, costruite – va detto – su basi comparative molto più solideFootnote 36 e con la consapevolezza che per la Forma Urbis è necessariamente applicabile il concetto di scala media.Footnote 37
È possibile, come è stato già osservato (Michel Reference Michel1983: 1010–1011), che Revillas e Nolli siano stati influenzati dai calcoli – anche questi errati – di Francesco Bianchini.Footnote 38 Nel libro postumo sul Palatino, il veronese ragiona sulla scala dei marmi e anch'egli trova corrispondenze esatte su riscontri sbagliati. Qui alle sviste consuete si aggiunge il confronto singolarissimo tra Sette Sale e Templum Pacis (colpevole la lettura cis[ternae] anziché [templum pa]cis del Bellori).Footnote 39 I rilevamenti riguardano la scala e le dimensioni degli Adonaea (fr. 46 a-d, e), ristretti per farli coincidere con il Giardino Spada, e inseriti nella fantasmagorica ricostruzione del colle.Footnote 40
Il rapporto in scala metrica implicito nei calcoli di Bianchini (1: 150.5)Footnote 41 è vicinissimo a quello sperimentato da Revillas e, anche se non vi sono indizi che il libro sul Palatino sia stato consultato o utilizzato, è possibile che il tema fosse stato in precedenza discusso tra i due studiosi?Footnote 42
L'ipotesi di scala per la sistemazione di Palazzo Nuovo venne poi affinata cercando un multiplo del piede romano che rivelasse il modulo e confermasse i calcoli. Il foglietto entro le pagine che compongono il foglio b (b1, Fig. 3) mostra che erano stati sperimentati i valori più vicini ai 110 palmi del confronto iniziale: 132 palmi, 11 once = 100 piedi romani e 105 palmi, 8 once = 80 piedi romani. Quest'ultima fu la scala grafica poi effettivamente apposta sul primo pannello dello scaloneFootnote 43 a materializzare una riduzione sbagliata.
È difficile dire se l'errore derivi solo dall'autorità di Bianchini, o se fosse piuttosto condivisa all'epoca l'idea che la pianta marmorea restituisse la rappresentazione di architetture non connesse da un tessuto comune e che in sostanza non fosse una ‘vera’ planimetria, ma qualcosa di assimilabile nell'articolazione ad un grande mosaico diviso in pannelli. Non si spiega altrimenti il disinteresse ‘metrologico’ per gli spazi non incisi e, soprattutto, la mancata attenzione all'ingombro che avrebbe avuto una pianta di città rappresentata in quelle proporzioni: una superficie di c. 375 m2, contro i già imponenti 250 m2 della grandezza effettiva, sulla parete del Foro della Pace.
A differenza di Bianchini, i cui calcoli servivano una tesi, gli sforzi di Revillas e Nolli erano finalizzati all'esecuzione di un lavoro e, nonostante il risultato, è difficile non ammirarne il metodo,Footnote 44 pragmatico e privo di preconcetti. Nella selezione ricavabile dal confronto tra i fogli a e b è possibile apprezzare le valutazioni realistiche che hanno accompagnato la scelta, per cui vengono ad esempio abbandonati due possibili ‘Settizodi’ (nessuno dei quali, naturalmente, il Settizodio) o l'improbabile ‘Hecatonstilum’ sul Celio e si scelgono piuttosto le architetture più articolate e riconoscibili insieme alle identificazioni all'epoca più accreditate.
Nelle misurazioni relative al Mausoleo di Augusto nel foglio b compare il riferimento ‘preso della mia pianta’: se è qui intesa la Pianta di Roma di Leonardo Bufalini, copiata per Revillas grazie all'interessamento di Capponi, ci troviamo a ridosso della scadenza per la sistemazione capitolina.Footnote 45 Questo spiega forse perché, nonostante fossero ben presenti i limiti della base documentaria a disposizione, cioè che ‘il libro del Bellori fatto con l'aiuto del Bufalini architetto è … più discorso Accademico, che fondato’,Footnote 46 i riscontri avvennero in ogni caso sulla vulgata che ne costituiva l'apparato critico.
Le identificazioni del ‘Bufalini architetto’ (Andrea) sono tuttavia scrupolosamente registrate nel foglio a,Footnote 47 ed è ragionevole pensare che anche di questa ichnographia si sia cercata copia.Footnote 48 L'approfondimento nella ricerca fu alla fine dunque uno solo, ma di grande valore metodologico: la Pianta di Roma dell'altro Bufalini, insieme ‘rottura ed origine’ nella storia delle rappresentazioni cartografiche di RomaFootnote 49 e che tra Forma Urbis e rilevamento nolliano rappresentava la fondamentale fase intermedia.
Il recupero della Pianta di Roma è, a posteriori, l'esito più importante dell'intera operazione, ma non si direbbe sia stata di grande utilità per il problema della riduzione in scala della pianta marmorea: era arrivata probabilmente troppo tardi, quando i tempi strettissimi imposti dall'operazione difficilmente potevano consentire una nuova analisi ed ulteriori sopralluoghi.
È possibile che nel tentativo di confronto tra frammento 35 m e sepolcro della via Labicana – la ‘Fabrica rotonda con tré scalinate’ – che testimonia quantomeno un tentativo di affrancarsi dalle interpretazioni di Bellori, si fosse cominciato a ragionare anche sulla pianta del Bufalini.Footnote 50 Nel complesso, tuttavia, la giornata passata a confrontare i dati (‘Per essere andato col R.mo P. Ab.e Revillas nella libraria di S. Agnese à rincontrare le tavole con d.a pianta’) deve essere stata priva di frutto.
I due fogli restituiscono, in conclusione, due momenti importanti del lavoro svolto e si confrontano con efficacia alla testimonianza contenuta nella nota delle fatighe del Nolli.
L'immagine complessiva è quella di un gruppo di lavoro organizzato e coeso: Nolli e il giovine provvedono ai rilevamenti; Nolli e Revillas confrontano i dati metrologici; meno definito il ruolo di Capponi, che pure approfondisce alcune ricerche (il 2 agosto 1742 controlla il codice Vaticano Latino 3439),Footnote 51 ed è presente anche, ad esempio al Colosseo, alle verifiche sul campo.
Il personaggio chiave, sia sul piano tecnico che su quello antiquario, è in ogni caso Revillas. Diversi indizi confermano il suo ragionamento scientifico su alcuni pannelli. Nel caso del progetto (novembre 1742; mai portato a conclusione) degli scavi per il cd. Circo di Adriano, il grande edificio venuto in luce a più riprese presso Castel S. Angelo (Liverani e Tomei, Reference Liverani and Tomei2005: 61–62), egli esplicitamente indica nei frammenti della Forma Urbis l'origine delle ricerche sul ‘circo’ vaticano.Footnote 52 Potrebbe essere un riferimento ad un'osservazione sorta nel corso della sistemazione dei marmi: il pannello XIX dello scalone di Palazzo Nuovo riporta la corretta sequenza di Settizodio e circo Massimo (Trendelenburg Reference Trendelenburg1872: 67), che sono invece ribaltati e privi di senso nella tavola belloriana corrispondente (Fig. 11a-b). Che vi sia stata una revisione di questo gruppo di frammenti è chiaro, ed è possibile che sia stata notata la mancata pertinenza del frammento 471 (Fig. 12) al circo Massimo, cosa che documentava di conseguenza un'altra grande struttura circiforme.Footnote 53

Fig. 11a. Bellori 1673, tav. XIX + Fig.11b: Foto Moscioni 8188 (Foto © Musei Vaticani).

Fig. 12. Pianta marmorea severiana, fr. 471 (foto © Sovrintendenza Capitolina).
Gli interventi topografici e gli accostamenti corretti che avevano suscitato l'apprezzamento di Heinrich Jordan possono forse essere attribuiti a Revillas,Footnote 54 mentre sicuramente più debole sembra fosse l'interesse di Nolli per i monumenti antichi.Footnote 55
Si direbbe anzi che l'incontro di Nolli con la Forma Urbis abbia poi condotto, nella Pianta Grande, a rappresentazioni poco attendibili proprio delle antichità oggetto di confronti e misurazioni: è il caso già citato del teatro di Marcello, ed è evidente nella rappresentazione delle ‘Septe’ lungo via del Corso. Qui al numero 852 in corrispondenza del Palazzo Pamhilj sono chiaramente rappresentati i frammenti 23 e 24 bc (il grande edificio di via Marmorata) e non le strutture effettivamente venute in luce a più riprese nell'area.Footnote 56
Tra i personaggi che ruotarono a diverso titolo attorno a questo gruppo (da Ferdinando Fuga e Pietro Forier allo ‘scarpellino’ Pietro Blasi), l'attenzione si è appuntata in particolare sul giovine assistente da quando è consolidata la sua identificazione con Giovanni Battista Piranesi.Footnote 57
Le critiche che Piranesi ebbe a fare in seguito, alla sistemazione capitolina ed allo stesso documento antico ‘opera di Professore inesperto’, non escludono necessariamente la sua partecipazione al lavoroFootnote 58 e potrebbero forse essere attribuite alla frustrazione di aver seduto a un tavolo al quale, per età e autorevolezza, aveva probabilmente avuto poca voce in capitolo. Le numerose corrette revisioniFootnote 59 rivelano una conoscenza materiale ed una familiarità concreta con la pianta marmorea tale da rendere l'identificazione estremamente plausibile.
Con Piranesi iniziano di fatto gli studi moderni sulla Forma Urbis e a lui dobbiamo, tra le altre cose, anche la memoria visiva dell'iscrizione relativa alla scala collocata in corrispondenza del primo pannello dello scalone di Palazzo Nuovo: Fragmenta ichnographiae antiquae Romae / prioribus XX tabulis comprehensa / eo sunt ordine quo a Bellorio edita / suppletis atq. Asterisco notatis /quae postea intercidere / Reliquae tabulae VI alia exhibent hactenus inedita / tabulae I adiecta est compendiaria pedum antiq rom LXXX mensura ex eorundem fragmentorum collatione / cum veteribus aedificiis deprompta. Footnote 60
La formulazione del testo non fu affare da poco. Revillas non era soddisfatto delle prime bozze, come si evince dallo scambio con Capponi,Footnote 61 in particolare ‘gli ultimi tre versi non esprimono ciò che dee darsi in ordine alla scala delle misure’ (15 agosto 1742) e, qualche giorno più tardi (26 agosto), insiste perché venga ricordato che ‘essendosi cavata questa Scala dal confronto de’ Marmi con molte delle Fabbriche da essi rappresentate, e tuttavia esistenti; pare necessario che nell'iscriz.e ciò venga accennato’.
Fin dal primo momento non sono mancate critiche e osservazioni su una sistemazione che pure ha alimentato lo studio e la fascinazione per il documento. Del risultato finale delle fatighe di Nolli e compagni rimane testimonianza visiva nelle foto del Fondo MoscioniFootnote 62 e bisogna ammettere che è testimonianza di un insuccesso. Il risultato rivela tutte le difficoltà di ‘materializzare’ delle tavole con disegni privi di scala, cosa che rendeva necessario enfatizzare oltre misura alcune copie di frammenti perduti per motivi compositivi o viceversa tagliare sezioni dei frammenti marmorei per contenerli nel quadro. Sono innegabili e note le sviste, le goffaggini, le copie inutili di frammenti conservati ma non riconosciuti, i danni compiuti. Il calcolo del rapporto di rappresentazione della scala è rimasto fino ad oggi l'unico successo limpido dell'operazione.
Occorre riconoscere invece che le critiche fatte da PiranesiFootnote 63 anche riguardo la riduzione in scala sono ingenerose e vaghe, ma corrette. Altrettanto può dirsi delle verbose obiezioni, pure fondate su conoscenze imperfette, che Charles-Marie De la Condamine fece al sieur Nolli nel 1775.Footnote 64
Revillas in quell'anno non era più in vita: rimangono i suoi appunti nella British School a testimoniare che anche il calcolo della scala fu un obiettivo mancato. I tempi a disposizione, la scarsa conoscenza del documento, la debolezza oggettiva delle basi documentarie e – forse – la fiducia eccessiva nell'autorità di Bianchini furono ingredienti di un inevitabile insuccesso: ma bisogna dire che fu un insuccesso di grande ingegno.
APPENDICE. ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, SACRO PALAZZO APOSTOLICO, COMPUTISTERIA, VOL. 230, N.66
Nota delle fatighe fatte e tempo impiegato dal geometra Gio B.a Nolli nell'unione de’ marmi della pianta antica di Roma donata al Museo Capitolino dalla Santità di N.S. Benedetto Papa XIV felicem.teregnante e posta in opera nel scalone del Campidoglio per ordine dell'Ill.mo Sigre March.e Capponi Presidente del sudetto.
Per aver impiegati sei giorni nelle stanze del Palazzo a Monte Cavallo à confrontare, e ritrovare li pezzi de’ marmi per venire in cognizione della loro unione 9,90
Per aver fatto il disegno della prima Tavola del Bellori ridotta dal piccolo in grande nella proporz.e de marmi 12,17
Per esser andato due giorni in più volte col giovine à riconoscere alcune misure nel Coloseo per poterne formare la scala alla presenza dell'Ill.mo Sig.re March.e Capponi 4,30
Per aver impiegati due giorni col giovine à contrasegnare le venti tavole per li pezzi che mancavano 4,30
Per aver fatto il disegno della tavola XIV ridotta dal piccolo in grande nella proporz.e che dovea essere in opera e fatto portare in Campidoglio acciò fosse veduto da N.S. 12,18
Per aver fatti li disegni di N° 82 pezzi mancanti nelle tavole e questi ridotti dal piccolo in grande con avere dilucidato le unioni de’ marmi à Monte Cavallo e fatti li cartoni, quali furono consegnati allo scarpellino per supplire i marmi, e per detti cartoni s’è impiegato un mese, e giorni venti di tempo col giovine 107,50
Per esser andato col giovine à S. Maria del Sole, ed à S. Maria Egiziana à misurare le sud.e chiese per confrontare la scala 3,00
Per esser andato col giovine al Palazzo dell'Ecc.mo Prencipe Pio in Campo di Fiori à misurare le vestigia dell'antico teatro di Pompeo per rincontrare la med.a scala 3,00
Per esser andato col giovine in Campo Marzo à misurare l'antico Mausoleo d'Augusto nel Palazzo del Sig.re March.e Corea, ed il colonato antico sotto il Campidoglio per rincontrare la sud. a scala 3,00
Per esser andato col giovine tre giorni à rincontrare la fabbrica delle Septe antiche nel Palazzo del Ecc.mo Prencipe Pamfili 6,75
Per essere andato col giovine à riconoscere, e rincontrare le vestigia dell'antico Teatro di Marcello per rincontrare la scala 3,00
Per essere andato col R.mo P. Ab.e Revillas nella Libraria Vaticana à rincontrare le tavole del Bellori 1,60
Per aver fatta diligenza per quattro giorni continui à cercare la pianta del Buffalini, e ritrovata nella Libraria di S. Agnese 6,60
Per essere andato col R.mo P. Ab.e Revillas nella libraria di S. Agnese à rincontrare le tavole con d.a pianta 1,65
Per essere andato due volte al Campidoglio col Sig.re Cavaglier Fuga per la disposizione delle sudette tavole 1,65
Per aver disegnato in grande le d.e tavole in una facciata dello scalone del Campidoglio a due idee accio fosse veduta la disposizione delle medeme dall'Il.mo Sig.re March.e Capponi per averne la sua approvazione, e del Sig.re Cavaglier Fuga 3,00
Per una giornata in Campidoglio col giovine impiegata in comporre di nuovo le sei tavole del residuo de pezzi non conosciuti dal Bellori 2,15
Spesi in carta imperiale, ed altra per dilucidare li sopradetti pezzi per le tavole 2,15
187,95
Le Sudd.e utili e necessarie fatighe fatte sono state considerate e concordemente saldate in scudi cento 100,00
A. G. Capponi Presid.e
D. Civitella M. di Casa
Mons.e Tes.re
II Comp.a spedisca il m.o a fav.e di Gio. Batta Nolli Geometra di scudi cento m. per saldo del p.nte conto delle fatiche fatte, e tempo impiegato nell'unione de’ marmi della pianta antica di Roma, posta in opera nello scalone del Museo capitolino d'ordine di Sua Snta, e distint.e da d. cont. aggiust. cosi d'accordo al quale &c Di Pal.o li 22 marzo 1743.
G. Colonna Mag.o